Sorry, this entry is only available in Italiano. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
TESTI CRITICI
Litaniando litaniando col suo triste verso prosastico, tra rime e assonanze, la filastrocca porta il grillo e la formica al cimitero, e Claudio Bonichi gioca di bianco e di nero col suo puntino a indovinare per filo e per segno, è proprio il caso di dire, il lustro e il lume dei suoi insetti innamorati. Ci riesce da poeta e da disegnatore che è dentro il brusio della natura, in quel gracile filo di zampe, di elitre che sembrano nascere spontaneamente dagli inchiostri neri o colorati e imprimere di sé quell’ansia vibratile, rattratta e sensibile.
Poche tavole, e non è il caso di gravarle con altre parole, ma quante bastano a fare dl Bonichi un illustratore col segno proprio dell’osservazione amorosa, da sperare impegnato in altre favole e in altre metamorfosi più vicino al mistero e al soprassalto dell’uomo, al gioco della luce e delle tenebre. Bonichi è sposo e figlio d’arte e vede nel foglio, per la sua scrittura, il mistero e il significato del bianco come avviene ai grandi viaggiatori delle estreme latitudini, dei labirinti e dei termitai, dove l’infinitamente grande e l‘infinitamente piccolo, la morte e la vita che rompe il seme per nascere, sono allo stesso punto.
Ma il discorso s’amplia, e non a caso. Bonichi lo ha provocato, a suo merito. E tutto è frutto di una memoria ancora giovane che si rifà all’adolescenza e all’infanzia, e, più lontano, a quell’incantato filo d’oblio in cui le scoperte degli occhi, ancora con gli occhi seguono il via-vai delle formiche bianche e delle formiche nere, e i grilli, i fili d’erba, le ciclopiche fatiche degli insetti, delle infinite vite che pullulano nella terra. Ostinazione e grazia e altre vischiose tenacie, proprie dell’incisore, sono all’origine di questa fiaba che in parole e in segni sbriga e trattiene gli affari della fantasia e i manierismi del novellatore.
Tutto è detto a puntino per quel che tocca sentire e vedere, e la commozione resta in bilico, detta e non detta nei diminutivi, per quei fatti che incalzano. Ogni verso è una nuova, una brutta nuova, ma la regia è esemplare, spedita verso l’azione. L’indugio vien poi, ed è della nostra memoria che torna al primo verso, mentre formiche e grilli sono passati nell’arte col proprio indelebile inchiostro.
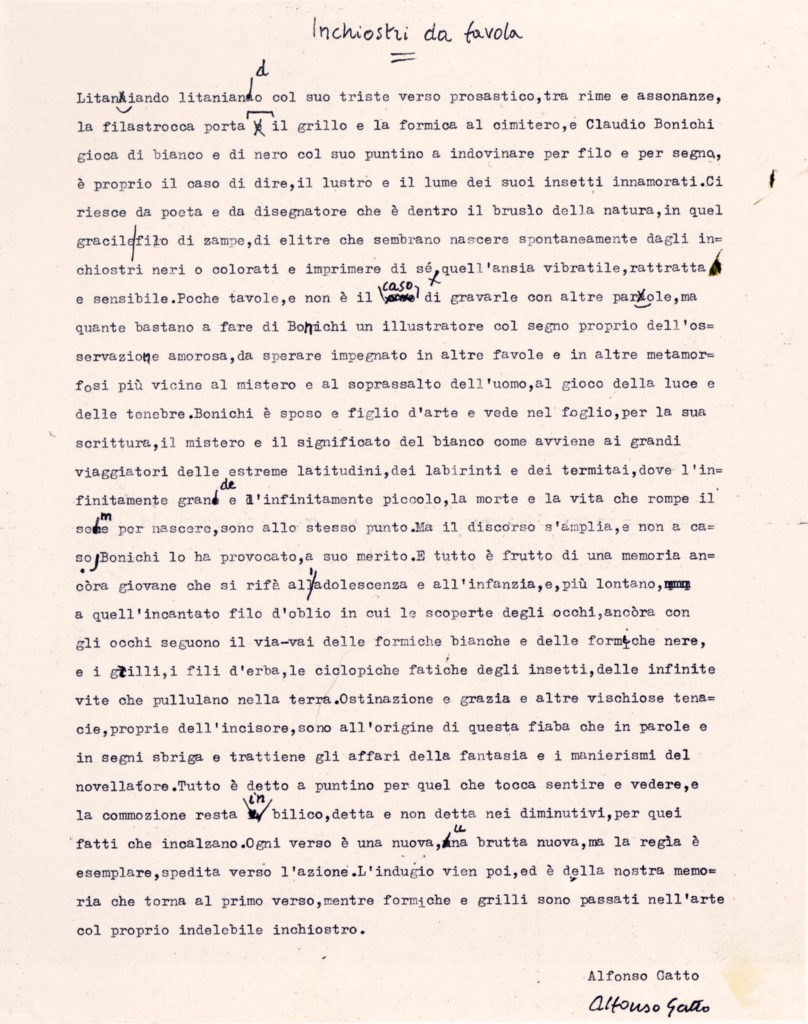


Un pittore e un poeta di altri Paesi, benché il primo si trovi ora a Barcellona e il secondo sia assente dalle nostre lingue, si sono incrociati nel centro dei miei interessi. Parlo del romano Claudio Bonichi, che espone nella Sala Parés, e di Tahar Ben Jelloun, il marocchino di cui è apparsa di recente a Parigi la sua “Poesie compléte”. E’ curioso: entrambi coincidono in una estetica trasparente, con adorni surrealisti, molto realismo e ampie zone di acuta sensibilità. Ben Jelloun è largamente noto da noi per i suoi romanzi, ma la sua poesia è sconosciuta, benché abbia pubblicato quindici libri dai quali scaturisce in modo essenziale la tematica della sua narrativa simbolista, intimista, tragica. Incominciò a scrivere versi nel 1966, al tempo di una rivolta studentesca a Rabat che lasciò morti e imprigionati. Ben Jalloun finì in un campo militare. “Avevamo 20 anni e facemmo il tirocinio della violenza e dell’odio”, ricorda. Diceva nella sua prima poesia: “Certo, la speranza non è un caffé preso in una sera d’estate / non è un ammicco che si fa alla storia / non è neppure un palazzo nell’orizzonte intimo, la speranza è / più di una idea vertebrale”. Nell’ultima poesia canta alla sua Città di Fez, persa, dove sono stato da poco, recondita e variopinta intensità del passato. Dice Ben Jelloun: “E’ grazie alle muraglie / Alle colline di santi e di morti / Che l’anima della città / È sempre viva / È a causa della bellezza / Di alcune donne e leggende / Che la solitudine / L’immensa cappa di sayal / La grande paura del vuoto / Non penetrò mai le viscere di Fez? / La città è lei stessa / Sovrana solitudine / Grandiosa e superba / Ogni pietra è una ferita / Una . storia mal raccontata”. Bonichi abita in via Margotta, dove abitò Fellini, dietro piazza di Spagna, ed è nipote di uno dei più grandi pittori dell’avanguardia italiana: Scipione. La sua opera è concepita con paziente saggezza, i suoi colori sono luminosi, precisi, sensibili. Un’opera che si distende attraverso due strade. La prima è quella dei suoi nudi femminili, coperta da una maschera di simbologia barocca e sotto la luce di una gelida luna: sì, Fellini e il Leopardi della nostalgia astrale, e il “Chi sono io?, come tentazione di una radice teatrale, un segno d’angoscia. La seconda, le nature morte di una qualità contenuta nell’espressione: se fossero più marcate potrebbero pervenire da Sanchez Cotan, se più terrose, assomigliare a Morandi, ma risulta evidente che è Bonichi. È una equilibrata mostra di quella pittura chiamata metafisica in Italia: il reale visibile fa risaltare l’invisibile nell’opacità dello spazio totale del quadro. Spesso, nel tramonto, guardo per un attimo una tela di Bonichi (un bicchiere con un fiore): guardo serenamente me stesso.
La Vanguardia, Barcellona, 5 Maggio 1995



Qualche anno fa, a Barcellona, dove l’arte sa ancora suscitare accese polemiche, nel corso di una intervista mi chiesero quale fosse la mia posizione nel conflitto tra realismo e avanguardia.
Domanda per me senza senso perché, per parlare di realismo, bisogna credere ciecamente nella realtà: ma che cosa è la realtà? O meglio, esiste una immagine oggettiva della realtà?
Ogni mattina entro nello studio, guardo gli oggetti lasciati il giorno prima e mi sembrano diversi; allora prendo la rosa, la mela, la modella, le isolo, le circondo di vuoto, le osservo da ogni lato quasi per capire il segreto del loro vero volto. Non sono fantasmi: l’ombra tenue e sottile che le accompagna è la prova della loro esistenza, ma questa metamorfosi continua e io dipingo, cancello, dipingo di nuovo, inseguendo e cercando di fissare ciò che credo di vedere.
Un fisico, a Ginevra, mi diceva: ” tu non vedi le cose, vedi la loro apparenza e la loro apparenza è fatta di luce: la luce cambia e le cose cambiano, o meglio, sembrano diverse. La cosa, lì davanti a te: la mela, la rosa, la tenera melagrana spaccata, non sono che un grumo di atomi, un cupo e misterioso groviglio di energia.
Tu non puoi vedere le cose, vedi la luce vaga che tocca le cose, o le sfiora, o le colpisce e poi rimbalza fino ai tuoi occhi: le cose sono come infinite piccole ingannevoli lune che possiamo ‘vedere’ solo perché brillano di tremula luce riflessa, e questo evanescente miraggio lo chiamiamo realtà.”
Kant, nella Critica della ragione pura, dice: “…ad esempio una rosa, viene intesa da una intelligenza empirica come una cosa in se stessa, la quale tuttavia, riguardo al colore, può apparire diversa ad ogni occhio…” e ancora: “…tutto ciò che noi chiamiamo oggetto si riduce a null’altro se non a semplici rappresentazioni della nostra sensibilità…”
Konrad Lorenz aggiunge: “…cogito ergo sum, penso quindi sono, questa è una certezza.
Ma chi può sapere, chi può dimostrare che il mondo variopinto che noi viviamo è anche esso una realtà? I sogni possono essere altrettanto variopinti e altrettanto ricchi di particolari e apparire convincentemente reali a chi sogna. Forse che tutto il mondo non è altro che un sogno?”
E Albert Einstein: “…attualmente non siamo in possesso di alcuna teoria deterministica che sia in grado di descrivere gli eventi in se stessi…”
Allora che cosa rimane da fare a me, pittore, che vivo di immagini e in immagini traduco ogni emozione? Fare quello che ho sempre fatto, con una piccola certezza in più: la curiosità, il senso di mistero, l’impotenza ad afferrare una qualche verità, che provo ogni volta di fronte al modello, non sono palesi segni di ingenua follia, ma il tormento di chiunque non usi gli occhi solo per vedere dove mette i piedi.
E poi c’è un altro inganno di cui finora non ho parlato: la memoria o Mnemosine, come la chiama Maurizio Fagiolo dell’Arco. Non so come sia per gli altri pittori, ma io non dipingo ciò che vedo o credo di vedere, ma ciò che ricordo di avere visto.
Il tempo della memoria può essere lunghissimo sino ad affondare nei primi ricordi dell’infanzia quanto brevissimo; la frazione di secondo che passa nel volgere lo sguardo dal modello alla tela è sufficiente a trasformare in ricordo ciò che quello sguardo ha visto.
Un meccanismo semplice che trasforma il fiume di sensazioni in emozioni. Questo flusso attraversa il corpo e si carica di visioni interiori, di paure, di tenerezze, di sogni, di scorie e quando arriva sulla tela il suo DNA è uguale al mio.
Mi seggo nello studio davanti al cavalletto, sul tavolino c’è una piccola mela bacata, accesa di colori: domani sarà sfatta e mi chiede di essere ricordata; la dipingo meglio che posso, credo di aver dipinto una mela, la chiamano natura morta e invece mi assomiglia, è il mio ritratto.
Ma quando dipingo penso a tutte queste cose? No.
Quando dipingo un quadro non penso a nulla di tutto questo. Ogni quadro è come se fosse il primo: non ci sono certezze, teorie o programmi di sorta. Dipingere diventa una specie di gioco d’amore con il soggetto che esclude la niente; l’occhio controlla, ma sono i sensi che guidano i gesti, una sorta di istinto.
Alla fine, esausto, non vedo quello che ho fatto ma, se mai, vedo quello che non ho fatto. Il vero tormento è lo scarto, lo scarto tra l’emozione e quel che ne rimane sulla tela.
Allora nasce un altro quadro e poi un altro e un altro ancora nel quale forse troveranno spazio le cose non dette.
Di questo discorso, o meglio di questo pasticcio fatto di realtà che, come la verità, se esiste non si svela, di apparenze, di sensi ingannati e di memoria, qual’è la soluzione? C’è una soluzione? Non c’è. Come diceva Stendhal: “…al di là di ciò che vuol fare, alla fine, ognuno fa solo quello che può…”
La memoria trasforma le cose, qualsiasi sia la loro natura, in una materia impalpabile che non conosce i confini tra verità e finzione, tra passato e presente, tra vivente e non vivente: una materia davvero simile a quella di cui sono fatti i sogni.
Roma, 1982
Presentazione della mostra, galleria il Gabbiano
1. Con quali nomi chiamare i colori della pittura di Bonichi? Direi, prima di tutto, che ogni quadro, preso a sé, e tutti assieme i quadri che mi mette davanti, parlano della chiara – ossia trasparente, luminosa -, inclinazione di Bonichi ad un certo monocromatismo. La domanda, di conseguenza, potrebbe porsi così: – con quale nome chiamare il colore della pittura di Bonichi? Tuttavia, a questo punto del suo lavoro, e della mia riflessione, non si può neanche dire che Bonichi si esprima mediante un vero e proprio monocromatismo. Nel suo caso si tratta, per ora, di un «certo» monocromatismo: dove «certo» sta per «ambiguo», e, forse, per «indeterminato». No: «indeterminato» non si dovrebbe proprio dire, del monocromatismo di Bonichi. L’aura delle pitture che sono davanti ai miei occhi è netta, essenziale, e, in questi quadri, nulla sembra tecnicamente inespresso, o lasciato pigramente al caso, e messo lì per creare capziosi equivoci.
2. La pittura di Bonichi è proprio di quelle che si fanno nella piena coscienza del minimo gesto, ed ogni accrescimento, ogni decurtazione in essa, equivalgono ad una scelta che proviene dall’oltre della soglia tecnica. Niente di «indeterminato», dunque, nei colori – o nel colore? – della pittura di Bonichi. Ma, allora, si può definire «ambiguo», il nomocromatismo di Bonichi, senza cadere in un altro errore? Forse sì, forse si può definire «ambiguo»: esso, infatti, non è autentico monocromatismo, dà l’impressione di volerlo essere, questo sì, e lancia radiazioni apparentemente su un’unica lunghezza d’onda, ma, in sostanza, i colori che concorrono a formare l’aura di queste pitture sono tanti, e non tutti, poi, così omonimi.
3. Ci si può, forse, avvicinare alla comprensione del colore – o dei colori? – di Bonichi, guardando meglio, ed osservando che in questi quadri «avviene» un dialogo fra un gruppo di colori dal quale Bonichi esclude quasi completamente i colori elementari: il rosso, il giallo, il blu. Questi tre grandi e prepotenti protagonisti, che tante urla hanno lanciato nello spettacolo «permanent» dell’arte moderna, sono confinati, nel dialogo fra i colori di Bonichi, ad un ruolo di comparse, o, al massimo, di figurazioni speciali.
4. Se una cosa è gialla, un limone, per esempio, allora venga il giallo, ma solo al fine di evitare malintesi. Solo perché il limone possa dire: – sono un limone.
5. Nessuna ambiguità, o indeterminatezza, a fronte del rosso, del giallo, del blu, da parte di Bonichi. Deliberatamente egli scansa la loro «primarietà» che può farsi sovente brutalità; ne ignora, o finge di ignorarne, il protagonismo; salta sopra i problemi storici connessi alla loro grammatica, e alla loro sintassi. Ma, in questa esclusione, non si nasconde, forse, un vizio di Bonichi, una sua tara, un non so che di malato ch’è in lui? Questa possibilità io devo ammetterla, io, che, non pittore, ma semplicemente «guardante», vedo, intorno a me, nello studio di Bonichi, e oltre, al di là delle vetrate, molti rossi, molti gialli e blu: tutti vocianti, bercianti, urlanti, ma «fuori» delle pitture di Bonichi. Devo ammettere che l’esclusione sistematica dei colori elementari, si compie già nella retina dell’occhio di Bonichi.
6. Potrei dire che l’inclinazione di Bonichi per il monocromatismo sembrerebbe acromatopsia. Bella scoperta! Tutti i pittori che si ri‑spettano, ossia tutti i pittori che in primo luogo pensano con il colore, sono, riguardo a noi semplici «guardanti», malati di acromatopsìa.
7. Domando a Bonichi: – Come chiamerebbe il colore dei suoi quadri? – Risponde Bonichi: – Color terra. – Obbietto: – Però, non c’è nessuna tela, fra tutte quelle che abbiamo davanti, che sembri ricoperta d’un colore veramente terra. – Bonichi dice: -Forse ha ragione. – Per spiegarsi, Bonichi prende la sua tavolozza e me la mostra; dice: – Guardi, questi sono i colori che adopero; prima di tutto il bianco, poi un po’ di nero per fare il grigio, terra d’ombra naturale, ocra gialla, ocra rossa, bleu inglese per certi sfondi.
Bonichi ha come l’aria di volersi scusare. Soggiunge, a bassa voce: – Tuttavia, se lei mi ripetesse la sua domanda, io risponderei sempre che le mie pitture sono color terra.
Io dico, indicando la figura d’una giovane donna nuda, nel quadro intitolato «Circo immaginario»: – E come chiamerebbe il colore del corpo di questa ragazza?
Senz’esitare, Bonichi risponde: -Color terra. – Ma io non mi dò per vinto: – Lei dice che il capezzolo, o l’areola, sono color terra? Sinceramente non mi pare, – dico, e, nel dir così, mi sento inquisitivo. Di che delitto si tratta? Del ratto e della presa in ostaggio del rosso, del giallo, del blu? Si pone, da un altro lato, il problema della sottoccupazione di tre grandi, operosi, popolari colori: solo un poco facinorosi.
8 Ma se fosse la mia vista a vedere troppo rosso, troppo giallo, troppo blu, dappertutto, tranne che nelle pitture di Bonichi? Io, come qualunque altro possibile «guardante», potrei soffrire d’una mia particolare forma di acromatopsìa, e, se Dio non voglia, mi mettessi a pitturare, ne fornirei certo una prova. Ma, il mio, sarebbe un «test» clinico: le pitture di Bonichi sono, invece, un «test» poetico. Il «colore» di Bonichi nasce da un’intuizione – e nell’incontro con le cose diventa idea, e le cose che Bonichi rappre- senta io posso vederle solo grazie all’idea che sono divenute.
9 Cosa vedo nelle pitture di Bonichi? In esse vedo svolgersi delle rappresentazioni che hanno un qualcosa di quel fittizio che solo gli oggetti di teatro, i fondali, ad esempio, hanno. Tali rappresentazioni si svolgono, se così si può dire, su due piani, o in due dimensioni, di cui mi pare evidente la contiguità, come se, tutte assieme, le pitture formassero un’ unica tela, componessero una sola, ininterrotta narrazione, scivolando le une dentro le altre, le «nature morte» introducendosi senza strepito accanto alle figure, e queste accogliendole con complice consapevolezza. Ma, se dico: – un qualcosa di quel fittizio che solo gli oggetti di teatro, i fondali, ad esempio, hanno, – se dico così, sono sicuro di esprimere quel che vedo? Sono sicuro di farmi capire, anzi di capirmi? La parola «teatro» è carica di valenze, e può essere molto fuorviante, non c’è dubbio. E non è esattamente al «teatro» che le pitture di Bonichi mi fanno pensare. Tuttavia, se la parola mi è venuta alla mente, una ragione ci sarà.
10. In queste rappresentazioni, Bonichi sembra interessato ad ordire alcuni suoi enigmi, ma per nulla tenebrosi, o minacciosi, o raccapriccianti. Ai miei occhi, il suo figurare non intende in alcun modo suggerire dei «nightmares», di quelli del surrealismo corrusco, che intimano al «guardante» un solo modo di sognare, se non di vegliare. Nessuna pittura di Bonichi mi dice: – Io sono il tuo incubo, – oppure: – io sono il tuo mondo circostante, il tuo umwell, – né si propone di de-strutturare il mio reale, alla maniera del versante paradossale del surrealismo. Bonichi non è un visionario, né un distruttore.
11. Vedo elencati da Bonichi, nelle «nature morte», con la cura d’un antico naturalista, insetti disseccati, che s’odono quasi cricchiare, pezzetti di sughero in abbandono, acini d’uva sul punto d’avvizzire, crepitanti fiori secchi, coppie di patate che appaiono molto intente a starsene immote nella loro terragna fissità, un fiammifero spento ed una vecchia sigaretta, separati da pochi centimetri, che, nel quadro, paiono diventare un abisso: l’elenco analitico, e non decadente, di quei secchi rimasugli della spazzatura d’un giardino al mare che il vento può per gioco trasportare in casa. Tutte queste cose gettano attorno piccole ombre a perpendicolo, meridiane, in una luce che meridiana non sembra voler essere, su superfici che diventano tali solo attraverso il contatto d’un oggetto, che, senza questo, resterebbero mere campiture.
12. Indico a Bonichi una delle campiture delle sue «nature morte». Gli chiedo: – Come la chiama, lei questa? e Bonichi sembra non capire, o credere di non aver capito. Dopo aver riflettuto, mi risponde: – La chiamo fondo. – Fa una pausa, ed aggiunge: – Oppure sfondo.
13.Anche io dirò «sfondo», per indicare lo spazio immateriale che circonda ed illumina queste due patate, e che si fa superficie tangibile solo attraverso il loro contatto, come succede alla memoria, quando, nel richiamare a sé un oggetto, s’illude di poter divenire essa stessa fatto oggettivo. Ma «sfondo» non si dice anche d’una scena teatrale?
14. Potremmo essere noi, queste due patate, Bonichi ed io, mentre discorriamo d’un suo viaggio a Cuba, di sentinelle del porto dell’Avana che giocano a carte coi passanti, o dei suoi figli, un maschio e tre femmine, che fanno a gara per portargli in casa carcasse di cavolaie e di stercorari, o mentre Bonichi parla della sua passione per il teatro, o per Ingres, o mi racconta delle sue prime esperienze di pittore, al seguito del nonno, cui era stata affidata l’esecuzione d’un affresco in una casa al mare. Potremmo benissimo essere noi due, Bonichi ed io, queste patate, a nostra insaputa. C’entra, questo, con la comprensione della pittura di Bonichi?
15. Da altre tele, più grandi, s’affacciano, come dal davanzale d’una finestra, alcune fanciulle a petto nudo. Esse hanno la testa travisata in maschere teatrali, tutte, salvo una, quella del «Circo immaginario», che, oltre al petto, mostra nuda anche la faccia, ed è l’unica, anche, a compiere un atto, anzi due: si porta uno zùfolo alle labbra, con la mano destra guantata di scuro, mentre con l’indice, il pollice ed il medio della mano sinistra, guantata di chiaro, mima la danza d’una ballerina in cilindro e tacchi a spillo. Quanti simboli, disseminati dappertutto! I guanti? Simbolo di purezza, ed anche d’investitura. I guanti bianchi, per di più sembra favoriscano il trasparire d’un benefico magnetismo emanante dalla punta delle dita. Il dito indice? Simboleggia la vita. Per una donna, esibire il petto nudo non è, come può apparire a prima vista, un gesto cli provocazione erotica, ma un’offerta d’umiliazione, un gesto di supplica. Attraverso la maschera teatrale pare che il «sé» universale trovi il suo modo più diretto per manifestarsi. Io, però, mi rifiuto di credere che Bonichi abbia voluto, come un qualsiasi astuto fabbricatore di rebus, caricare di tanti significati occulti le sue pur trasparenti figurazioni. La cosmogonia di Bonichi dà di sé un’immagine così intima, e umana, e pudica, da non poter apparire altro da quella che è: una cosmogonica familiare. Infatti, la domanda è questa: hanno, gli enigmi di Bonichi, voglia d’essere sciolti? E poi: cosa mi fa credere che le pitture di Bonichi realmente contengano enigmi?
16. Ecco che sono giunto a stringere un pugno di mosche. Certo, è difficile avvicinarsi onestamente all’opera d’un artista per cercare di comprenderla. Ma ho proprio sbagliato tutto? Eppure, qualcosa credevo d’averla afferrata: il suo cangiante monocromatismo, ad esempio, quel suo lieve tanfo di teatralità, immaterialità degli «sfondi», che si fanno materia tangibile nell’apprensione d’un oggetto della memoria, e poi, e poi? E poi, qualcosa che attiene al mare come una leggera brezza marina che spiri fra queste cose, questi limoni, queste lenzuola da bagno, queste terrazze, ed anche fra queste ragazze, che forse sono epifanie femminili d’una lontana estate al mare, ragazze d’un tiro a segno litoraneo, piccole stròloghe da spiaggia, acrobate del piccolo circo accampato in mezzo al tomboleto, domatrici di pulci, occasionali prostitute che fanno capolino di tra le sconnessure d’un capannotto, forse regolari bagnine. Mi vien voglia, ora, di ricominciare la visita daccapo: ma non più dallo studio di Bonichi. Sono penetrato in una ventosa casa al mare, dalle grandi stanze aperte su un giardino di sabbia, forse disabitate, certo, in questo momento, deserte. I muri sono percorsi da un affresco ininterrotto, entro cui un uomo, a me ed a se stesso ignoto, è andato aprendo e chiudendo spiragli sulla vita di bambino in quei luoghi, in quella casa, in quel vento marino, divertendosi, come alla caccia di farfalle, a catturare la miticità delle sue prime conoscenze e fantasie, una bagnina si trasforma in Proserpina, una faccia è maschera indrcifrata, e tutti gli oggetti vanno nominati, riconosciuti, catalogati, perché possano diventare reali, anche una rosa morente, ed una cavolaia alla fine del suo ciclo. L’aria di mare ha messo la sua ultima velatura sui colori dell’affresco, li ha stemperati, e l’occhio li coglie come fossero un unico colore. Così è, sempre, negli affreschi, poiché lo stesso muro rastrema i colori, li riduce alla sua porosità, al suo colore, li doma. Vado di stanza in stanza, seguo l’itinerario dell’affresco «quasi» monocromatico, che si svolge come una rappresentazione teatrale. L’affresco è anche teatro. La memoria è anche teatro. E, giunto nell’ultima stanza, trovo gli attrezzi del pittore deposti in terra, davanti ad una parte incompiuta dell’affresco, la più misteriosa, una gran donna nuda con una piccola maschera, che fa da eco alla macchia nera del pube, una gran donna neoclassica dal gran ventre, forse la madre, anche uno spiraglio di tra le quinte del teatro della memoria, un gran corpo chiaro disteso su un gran letto di vele bianche, come spossato da misteriosi languori muliebri. Forse è qui l’incontro del colore di Bonichi con le cose, qui, la sua idea: nelle stazioni d’un affresco fantasticato con gli occhi della propria infanzia, dentro la grande, ventosa casa marina della pubertà.



Claudio Bonichi dipinge nature morte e figure, così come ogni pittore della tradizione ha fatto. Ma le sue figure appartengono al genere pittorico dei “capricci”, e le nature morte sono veri e propri oboli funerari.
Nel “capriccio” la figura viene iscritta in una situazione che ha a che fare con il mondo del sogno, o in un mondo fantastico la cui grammatica è prevalentemente simbolica ed esoterica.
Per trovare un’origine al “capriccio” bisogna risalire al Rinascimento e alle acqueforti di Dürer, al loro immagato sentimento misantropico. Ma è Goya a essere stato il maestro illustre di quel genere pittorico così come esso si è configurato nella sensibilità moderna. In Goya l’irruzione della fantasia sulla superficie pittorica situa le figure in parabole allegoriche svincolate da ogni lessico, le sfrangia di sottintesi polemici, le nutre di contenuti eccessivi per la stessa occasione che sembra averle partorite, e la vita con il suo corso bruciante le rende incandescenti.
Nella figuratività di Bonichi la tentazione del sogno e del simbolo è evidentissima—… il sogno dell’impossibilità di guardarsi, scorgersi, conoscersi, farsi conoscere …
…Nei “capricci” i contenuti sono sempre chiarissimi e insieme sfuggenti, determinati ma vaghi, anche insidiosi per troppe valenze. Nei “capricci” di Bonichi, la maschera è un dato ricorrente; come altro dato ricorrente è la nudità dipinta con tale sapienza da sfidare l’incorporeo: …se ne potrebbero ricavare varie interpretazioni — certamente, su tutte dominerebbe quella che segnalasse il carnevale come un momento privilegiato della malinconia e della nevrosi.
… Mascherarsi e guardarsi è un’ossessione che replicandosi pare deludere il personaggio che Bonichi invita al ritratto sulla propria tela — e il risultato è l’impossibilità stessa del ritratto: un corpo tutto sommato simile a tanti altri corpi, e una maschera dove l’unica cosa che vi si stampa sopra è ovviamente la credibile assenza della persona.
Altro singolare “capriccio” bonichiano è quello dove, frontalmente, vediamo un devastato teatro da bambini, — … L’arlecchino è andato distrutto: … niente scene, solo quinte rosicchiate: …non c’è altro. Se la vita è teatro, questo teatro non è che la copia in scala ridotta di se stesso — piccolo relitto o piccola maceria o obolo funerario di un passato del tutto naufragato.
“Capricci”, o anche “Vanitates”, — tale era la definizione che la tradizione dava di questo tipo di pitture. “Vanitas” veniva anche chiamata la “natura morta”; e “vanitas”, sul dizionario latino, significa, oltretutto, “vuoto”. Vuoto metafisico e nulla, allarmanti presenze e simboli possono coincidere in un mistico cerchio.
Difatti. Un “capriccioso” simbolismo mi pare lentamente erodere in Bonichi ogni possibilità concreta di vita. Oppure, trascina il pittore verso una oscillazione ai cui capi c’è da un lato l’onirica visione dei corpi, nudi e mascherati, comunque truccati per la scena impossibile dell’esistenza; dall’altro, l’esistenza nella sua devastata purezza, mostrata nei suoi minimi termini concreti, un tralcio di roselline essiccate dall’aria, un raspo di uva privo di acini, un mazzetto di anemoni che l’acqua ha marcito piano piano; o sono frutta che si specchiano in una psiche dove l’argento si tinge del rosacenere del nulla.
Oboli di morte e oboli alla morte — Bonichi dipinge la delicatezza crepuscolare di una fine. Ma ciò che dipinge non è la luce occidua o l’incerta intermittenza antelucana. Bonichi dipinge la fermezza simbolica del crepuscolo: il suo segno, la sua materia palpitano di interiorità non per impressionistica maniera. Il suo pennello ricerca soluzioni persino cristalline, levigate, cifrate dentro maniacali rifiniture; e in quel rifinire ci sono scaglie di luce che niente può fermare, o il distruggersi di ogni luce sul punto di fuga della polvere.
I primi attori che recitano sul palcoscenico color latte inventato dal pittore Claudio Bonichi sono: il grappolo d’uva, la fetta di anguria, i garofani della Riviera, il melograno e il ribes rosso, le pere rosse e quelle gialle, le bocche di leone. E il narciso, purché sia appassito.
Talvolta Claudio Bonichi ha fatto recitare anche dei grandi nudi femminili ai quali ha spesso imposto di nascondere il viso dietro una maschera. In quei corpi nudi e allungati in un letto, tra lenzuola e capelli molto ben raccontati, la carne mai appassita di quelle adolescenti forme era così evidente che al pittore non restava altro da fare che nascondere quell’esile dettaglio chiamato volto, l’altro dettaglio che sta negli occhi, nello sguardo di quegli occhi che guardano sopratutto quando sono chiusi per la sonnolenza. E nascosti dietro una maschera.
Ma i protagonisti, i capocomici, i primi attori, i solisti sono, come abbiamo detto all’inizio, gli steli, i rametti, i gambi, i fiori appena nati o lasciati andare fino alla consunzione nel loro museo di storia naturale. Qualcuno di quegli attori si è fatto sbucciare o inghiottire a morsi, da commedianti acerbi o maturi. Ma i protagonisti sono loro: i frutti. La frutta.
Guardando senza fretta qualcuno di loro allungato su quel palcoscenico colore del latte ho sentito parlare l’anguria. Temeva per se stessa, all’idea di restare per troppo tempo sulla scena, perché le sue goccioline si sarebbero potute perdere tra le assi di quel teatro e perdere qualche seme, quei bellissimi semi color marrone, duri e levigati come gioielli da scavo, e così numerosi da sembrare, anche se una sola fetta di anguria era in scena, un popolo di piccoli attori neonati che stavano beati in quell’ acqua colorata di rosa, profumata e appiccicosa che è l’anguria.
Water mellon. Così è chiamata. E proprio questo mi ha raccontato l’anguria: del suo timore di disfarsi stando troppo in scena. Lo stesso timore prendeva i funghi. Ma i Funghi, forti del loro fortissimo profumo penetrante, resistevano per giorni interi, portandosi addosso quel poco di terriccio che solo l’ultimo dei cuochi avrebbe osato togliere: perché quel terriccio doveva stare addosso a quei forti gambi, ossatura di quei personaggi.
***
Il grappolo di uva. Mai famiglia reale e teatrale è stata più unita degli acini di un grappolo d’uva. Ma ascoltando attentamente la loro conversazione non li sentivo parlare ma cantare in
coro. Sommessi. Qualcuno si staccava dal gruppo, ma senza uscir di casa perché i rametti, chiedo scusa: i tralci che sono il legame che li ha messi al mondo, legati insieme su quel palcoscenico, sono loro che danno l’intonazione: a tutti quanti i chicchi di quell’uva matura e nera, rallegrata da qualche nuvoletta di polverina bianca — anticrittogamica? — spruzzata perché la loro voce non calasse mai, nonostante le lunghe recite, di una ottava. E su quel palcoscenico, tutte le volte che restavo incantato davanti a quei quadri, gli acini d’uva mi dicevano che, per loro, il mondo, l’intero mondo non fosse mai cambiato: e che nessuna guerra, cataclisma o dissapore tra le famiglie dell’uva fosse mai riuscito a stravolgerli, a farli cambiar d’umore, o ad alterare la loro fisionomia. L’uva era rimasta tale e quale nonostante la guerra di religione. Quella era l’uva, e quelli erano rimasti gli acini: intatti.
Il suo punto di vista. Quando dipinge gli attori che recitano la parte della frutta, Claudio Bonichi siede di preferenza in fondo alla sala.
Le voci dei suoi attori, anche quando stanno mezzi annegati nei bicchieri d’acqua si fanno sentire: tanto è vero che il suo modo di ritrarli non somiglia ad altre tecniche note. Bonichi, dal fondo di quella sala, insegna alla frutta e ai fiori il modo giusto per appassire, e quale aspetto o comportamento devono tenere le foglie, o i petali, già caduti a terra.
Se guardiamo, insieme a Bonichi, e quindi dal fondo della sala i suoi attori, il “Grappolo di uva”, la “Uvas de Binissalem” che è un olio su tela del 1995, così come gli altri “Il peperone e l’aglio” o le “Gra-nadas”, noi vediamo sempre da lontano il suo spettacolo di pittore e quello che si vede affiorare da quel fondale colore del latte non è mai in primo piano. Ma l’aria che sta su quel palcoscenico è sempre trasparente, e l’acqua che sta in quei vasetti, come l’aria che esala da quella scena sono, da sempre, i migliori “a solo” di pittore che io ricordi. Bonichi fa stare soli, come primi attori, tutti i suoi personaggi. Credo che fra i “Guinness dei suoi primati” ci sia sempre il bicchiere con dentro qualcosa, l’Iris, le Violaciocche o quell’Insetto morto nel deserto” dedicato a Ligi Carluccio: l’unico ritratto di un palcoscenico montagnoso dove Bonichi ha dipinto la minima cosa che gli serve: vedere tutto da lontano, come l’annunciazione.
Ma Bonichi lo sa fare il panneggio?
A questa domanda del repertorio classico di Giorgio de Chirico, lo stesso pictor optimus avrebbe risposto affermativamente. Infatti, quando si affacciano i quadri dei corpi non sono meno dipinti di quelle lenzuola stropicciate: almeno quanto i bagliori della carne adolescente di quei “Giochi di soffitta” del 1986. Perché, quando Claudio Bonichi si allontana dal vasetto del suo grappolo di glicine, lo fa per essere libero di descrivere quei corpi. E se la frutta è spesso sdraiata come un corpo che si sta riposando, i frutti delle sue ragazze, quella “Naiade a Palma” del 1996 dedicata a Boecklin, per il suo volo stellare nel cielo, quella “Naiade” a me ricorda il sogno di Icaro sconfitto dal sole…


Per Claudio Bonichi
O vili posteri
qui vi si mostra
un “artifex”
che in altra Roma
sarebbe parso divino:
Claudio Bonichi.
Le civiltà in sfacelo
lo costrinsero
a giocare con miseri balocchi
velieri naufragati •
tramonti sgangherati
ex-libris abbruciati
linee sottili
anime guaste
cieli e colori inquieti
e il nulla
che voi siete
Giovanni Arpino, 14 ottobre 1982



La materia pittorica, che è la sostanza della grande pittura,
possiede il suo lato profondamente metafisico,
e l’elemento metafisico della materia pittorica
è quel fenomeno misterioso e sacro
che ci mette di fronte al Talento Universale
e ci permette di vedere un mondo migliore,
un mondo che ci consola delle miserie e delle banalità degli uomini;
un mondo superiore, eterno e perfetto ove regna il genio.
Giorgio de Chirico, Discorso sulla materia pittorica, 1942
La pittura metafisica è un genere aristocratico atteso dai molti enigmi disseminati oltre l’orizzonte del visibile. Sospesa nel cielo della filosofia, essa si caratterizza per una tensione endogena distintamente percepibile, che interviene, austera, ad accrescere la temperatura spirituale di una selezionata varietà di soggetti: ora luoghi abitati da un’evocativa assenza, ora cose adagiate in silenziosi interni ove aleggia una sibillina solitudine.
In tali ambiti remoti – spazi perlopiù suscitati dal connubio fra immaginazione e memoria –, quanto avviene, è avvenuto o forse solo avverrà per trame fatalmente immateriali, è scandito con sorprendenti orchestrazioni dalla luce: vi collimano bagliori dall’origine indecifrabile, riverberi improvvisi; ombre in cui si celano entità e, più spesso, presagi ambigui.
Un senso di disorientamento sopraggiunge, repentino, in chi si pone al cospetto di simili rappresentazioni, abilmente elucubrate come fossero visioni di un altrove immaginifico, la cui vicinanza con la realtà, associata all’ermetica apparenza, alimenta una fertile moltitudine di incanti e di illusioni.
Accadono, così, prodigi che la pittura estende al di là del complesso visivo, in quei territori della mente dove, a un tratto, riprendono a echeggiare suoni e a diffondersi aromi risvegliati da sublimi simulacri di una temporalità magica, virtualmente esistente.
Eppure, nonostante la peculiare connotazione, esegesi costellate da alcuni ricorrenti equivoci insistono, stucchevoli, in questo rarefatto ambito espressivo. Si è soliti infatti riferirsi – superficialmente – a una generica metafisica, quando ciò di cui si sta dibattendo riguarda più propriamente l’intonazione, invero accentuata, di una particolarissima pittura, informata da ordini vertiginosi e da una severità antica, subito eloquenti nella cura maniacale per gli impasti e nella sopraffina stesura della materia, nonché nel ricorso abituale a cromie e trasparenze inusitate che indovini realizzate con lentezza di clessidra.
Un talento smisurato e un’indole estranea all’appagamento sono dunque necessari a chi scelga di dipingere in questo olimpico contesto, dove titani dell’arte di ogni epoca ci accompagnano con capolavori memorabili, la cui perpetua attualità attesta l’evidenza di un altro corrente fraintendimento, ovvero che vi sia una pittura metafisica di ieri e una di oggi. Viene da chiedersi: come non considerare tutte contemporanee, sebbene dipinte fra il Quattrocento e i giorni a noi più prossimi, scene e ambientazioni meditate in una sospensione del tempo profondamente aurorale? Il Sogno di Costantino e la Flagellazione di Cristo di Piero della Francesca, gli interni di Vermeer, le nature morte di Chardin e quelle di Morandi, così come le isole di Böcklin e le piazze di de Chirico non appartengono, forse, alla medesima idea e a un identico spirito che ritroviamo – ad esempio – nei lavori di Armodio, Ferroni, Luino, Modica e Tonelli?
Altra stagnante approssimazione è quella di reputare unica e determinata la prospettiva, all’inverso sconfinata, di un’investigazione pittorica orientata verso, almeno, tre differenti angolature – luoghi, cose, la stessa esistenza –, modelli sovente trasformati, attraverso intriganti metamorfosi, in loro arcane similitudini.
L’ossimoro, peraltro, in più d’una circostanza contraddistingue la narrazione vagheggiata e straniante di un’iconografia nella quale, simultanei, sciamano archetipi e verità ultime: pensi al segreto idillio nella misteriosa Tempesta di Giorgione, a ciò che vedi o credi di vedere, e subito balena l’eterno interrogativo: et quid amabo nisi quod rerum aenigma est? (e che cosa amerò se non l’enigma delle cose?)
L’urgenza, intima, ci interessi fino a un certo punto. A rendere davvero metafisica un’opera d’arte, è sempre e comunque la pittura.
Del resto, cos’altro, se non la pittura o più della pittura, può diventare comune riferimento per autori fra loro tanto distanti come quelli che si è deciso di presentare in questa singolare mostra?
Spesso oggetto di malintesi sono, infatti, le affinità che è dato di cogliere limitandosi al solo figurato: tra le cose di Armodio e quelle di Guarienti o di Ferroni; dentro le stanze – e dinanzi alle figure femminili – di Faini, Luino, Bonichi o Modica; nelle architetture e nei luoghi, memori del Quattrocento urbinate, di Rampinelli e Tonelli.
Il pittore più propriamente riconducibile a una ricerca metafisica è evidentemente Armodio. Altri, a cominciare da Ferroni, vi convergono passando attraverso un realismo esistenziale in cui albergano curiose analogie con Balthus (Faini e Luino) e con Hopper (Tonelli), mentre un’aura mediterranea, così come si è abituati ad avvertire nell’opera di Savinio e di de Chirico, è tipica del lavoro di Modica, il cui mare imperscrutabile è tutt’altro che dicotomico rispetto alle acque trasparenti di Hockney.
Non stupisca, in questo senso, il riferimento a qualche rinomato artefice vivente – un altro: López García, per la stima che egli ha di Bonichi –, di fatto estraneo a simili implicazioni, poiché ciò che è nostra intenzione affermare è l’appartenenza di questi rari autori italiani ad una resistenza, quella della pittura, divenuta, ormai, un fatto internazionale.
L’incombente è quanto hanno scelto di indagare tali valorosi pittori, approfondendo, ognuno di loro, divergenti indizi: la nebbia dell’oblio scesa sui ricordi (Guarienti); l’ultimo istante di vita di fiori, frutta o sigarette nel posacenere (Bonichi); l’anima interna degli oggetti (Armodio); il caldo tepore della presenza umana – o giusto la percezione del suo fantasma – tra le pareti domestiche (Faini, Luino, Modica e Ferroni); la dimensione atemporale di contesti urbani o periferici risorti in una predizione perenne (Tonelli e Rampinelli).
L’esito è un teatro mentale costruito non senza fare ricorso a luci e ombre allusive. Le comprendi eloquenti ove serva esserlo, al pari di umori e odori che immagini pullulare nell’aria: fragranze di agrumi e di salsedine (Modica); antiche alchimie padane (Armodio); polvere e tabacco (Bonichi). Fino a quel senso, modulato e struggente, che ingenera «ciò che è stato da poco» (Luino) – straordinariamente emblematico nel Letto sfatto di Ferroni (pag. ???) –, in ultimo esauritosi nelle appartate e pacificate consuetudini di Faini e sul sudario della realtà, al contrario denso di variegate impronte, di Guarienti.
In un altro versante, ecco, infine, il mondo di Rampinelli e quello di Tonelli. Vi si accede con l’oscura trepidazione di chi si accinge a fare una scoperta oppure un incontro non preventivato. Qualcosa ci attende, ma non sappiamo cosa. Una volta entrati, ecco l’imperturbabile atmosfera dell’eden di Rampinelli e l’essenziale metafisica dell’Autoritratto – come delle fabbriche, i muri, i palazzi – di Tonelli.
Miracoli della pittura: quando è davvero tale.
Firenze, ottobre 2011
Nell’universo metafisico della pittura di Claudio Bonichi emerge per primo il dato poetico.
L’idea lirica sottende tutto il suo percorso, a cominciare da quel 1964, quando Bonichi
presenta la sua prima personale alla Galleria Sant’Andrea di Savona.
La nota poetica delle immagini, avvalorata da un esteso, tangibile silenzio, tende poi a
confondersi con il senso di mistero e di sospensione che emerge da esse.
Il grafismo preciso lo porta a riflettere in continuazione sulle cose, sulle immagini, ad
appuntare, a imprimere nella memoria e a tirar fuori da essa tutti i dettagli di un sogno o di
una favola, che illustra sulle tele e ripercorre. Non a caso Alfonso Gatto definisce Bonichi
illustratore “col segno proprio dell’osservazione amorosa”; non a caso è indotto a sperare
che l’artista fosse “impegnato in altre favole e in altre metamorfosi più vicine al mistero e al
soprassalto dell’uomo”, lui che aveva prestato la sua immaginazione per Il grillo e la formica.
Oggetti che si rompono, frutti che si spaccano, quasi a mostrare il proprio nerbo, illusioni
fantastiche di improbabili unioni di corpi di uomini e donne e di maschere e di cose, in un
illusivo mondo proprio. È molto semplice andare con la mente alle opere surrealiste di
Magritte, a certe ombre o a certe silhouettes di Dalì o alle composizioni metafisiche di De
Chirico. Altre soluzioni ci ricordano ancora il fiamminghismo di Antonio Bueno o le gamme
monocrome di Morandi.
Tuttavia, gli oggetti che ricorrono nel repertorio di Bonichi sono ancora più attualizzati:
mozziconi di sigarette rovesciati da una ciotola, grappoli d’uva mezzi mangiati, bambole,
peluches, anelli d’argento all’ultima moda che, rompendo la magia di una scena atemporale,
ci riportano in un attimo nel nostro vissuto. A questi si coniugano le maschere: nella
Maschera di Narciso del 1990 o nella Maschera bianca e mela dorata del 1993 il gioco del
rimando della maschera si unisce a quello del riflesso dello specchio, uno specchio non
ideale, bensì facilmente individuabile con la sua cornice di legno e il gancio in ferro per
essere appeso.
Quella che propone ancora oggi Bonichi è un’antologica mitopoiesi di grande fascino, in cui
l’anima classica si fonda su un uso del colore raffinato, tendente a una tonalità monocroma media e a una resa sottile e quasi trasparente dell’immagine.
Isabella Valente
Docente di Storia dell’Arte Contemporanea
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Parigi
L’Italie est une belle terre des Républiques de l’Art : Venise, Amalfi , Naples, Rome ,Florence … Les artistes sont la fierté de leurs familles.. Le quotidien est respecté comme une œuvre d’art.
Vu de Paris, nous entendons ces belles ondes de la pensée, elles nous sourient et nous nourrissent depuis longtemps.
Avec la famille Peluzzi Bonichi, nous voilà au cœur du xx siècle avec ses quatre générations d’artistes qui nous font partager leur sens de l’humain, de la représentation du vivant et ses marques secrètes derrière ces personnages qui nous saluent .Le musée du Montparnasse tenait à honorer cette lignée de talents qui nous fait vivre et mieux comprendre cette sérénité du temps , le temps d’une Italie éclairée et amie de cette capitale cosmopolite … Parigi
Jean Digne
Paris
L’Italia è una bella terra tra le Repubbliche dell’Arte : Venezia, Amalfi, Napoli, Roma, Firenze… Gli
Artisti sono la fierezza delle loro famiglie…Il quotidiano è rispettato come un’opera d’arte.
Visto da Parigi, noi dilatiamo queste belle onde del pensiero, esse ci sorrridonono e ci nutrono da
lungo tempo.
Con la famiglia Peluzzi Bonichi, eccoci nel cuore del XX secolo con quattro generazioni di artisti che ci
permettono di condividere il loro senso dell’umano, della loro rappresentazione della vita e dei suoi segni segreti, nascosti dietro questi personaggi che ci salutano. Il Museo di Montparnasse voleva onorare questa linea di talenti che ci fa vivere e meglio comprendere questa serenità del tempo,
Il tempo di una Italia amica ed illuminata da questa capitale cosmopolita…Paris.
Jean Digne
In uno splendido pomeriggio del maggio 2009, nella casa-atelier di Claudio, in Largo Arenula in Roma, si parla degli spiriti, degli oracoli e della pittura in tonalità di ocra e cobalto. I teschi sul pianoforte e i magnifici cani distesi nel suo nuovo atelier sono la cornice surreale dei nostri colloqui. Beviamo gin-tonic con fette di limone. Eh si,…, mi fa piacere pensare al limone dipinto nella sua natura morta: “Limone con matita” del 2007. Mi ricordo ancora del suo racconto trascendentale dei fantasmi piromani nel suo atelier della Piazza di Pietra con la vista sulle colonne corinzie adornate con i fogli d’accanto del Tempio di Adriano.
Capri. Il tramonto ocra. Fiori blu cobalto del Myosotis alpestris sullo sfondo marino provocano una vibrazione che altera lo stato di coscienza di Claudio, e crea una esperienza sciamanicha indimenticabile. Le vibrazioni dei colori d’ocra e cobalto evocano la forma di spiritualità più antica del mondo. In questo momento magico, Claudio incontra gli Spiriti, con il Viaggio dentro la Realtà Altra, una sapienza atavica in cui pittura, magia e mistica sono inestricabilmente intrecciate.
Questa atmosfera del tramonto in Capri, evoca le vibrazioni dall’allegro andante fino al maestoso, con grande forza in tonalità cobalto e ocra. Le stesse onde trascendentali dei dipinti di Altamira, Lascaux e Fayoum si riscontrano oggi nella pittura di Claudio Bonichi.
Nature morti, collage con i petali blu delle hortensie e il verde fogliame essiccato del suo herbarium con ricordi pittorici del paese dove fioriscono i limoni. Il suo concerto pittorico è un racconto poetico, fatto di ricordi e sensazioni trascendentali.
“Non capisco più. È il mio speccho”, 2000
Su tutto comunque domina il sofisticato, elegantissimo controllo della linea sfuggente con tenere ombre degli occhiali rotte. La capricciosa forma degli occhiali è definita con nitida precisione di artista. Questi strumenti a volte ci aiutano a guardare meglio. Una macchia nera o una sagoma di mosca morta, cinque cerchi forse non casualmente olimpionici creati timbrando la carta con la tazza di caffé creano una riflessione sulla nostra capacita limitata della visione del mondo. Possiamo vedere meglio? Chiudendo gli occhi: SI!
”Le ortensie del suo giardino”, 2006
È proprio vero che una pagina di Herbarium può diventare un’opera d’arte. Qui il racconto è più profondo, velato e intimo.
Visconti nel Gattopardo descrive i cerimoniali dei Salina come delle principesche nature morte o delle repliche di quadri famosi, come accade con la scena del picnic che riproduce fedelmente Le dejeuneur sur l’érbe di Manet.
A questo punto le Hortensie del suo giardino creano un ricordo associativo, un vero link mnemonico, dove un artista fa omaggiò ad un’ altro con i fiori del suo giardino caprese.
John Jan Popovic)
Roma, sabato 23 maggio 2009
A volte, i sogni si realizzano. Parlo per me, naturalmente, perché la storia di quest’idea è molto antica, nel senso che risale a diversi anni or sono, quando nacque in me il proposito di presentare un singolare progetto culturale all’amministrazione di un piccolo paese del Lazio, cui sono molto affezionato in quanto cittadina di origine di mia moglie e mia nonna: Veroli. Per organizzare un evento culturale degno di questo nome, pensai che un’occasione interessante poteva essere realizzare un’esposizione con le opere non di un artista, ma di una generazione di artisti; anzi di varie generazioni di pittori, meglio se appartenenti ad una stessa famiglia. Un’impresa tutt’altro che semplice perché, oggi come oggi, non ci sono più le botteghe d’arte nelle quali il mestiere passa di padre in figlio, come accadeva per i Pisano, Nicola padre e Giovanni figlio, oppure per i Bellini, Pietro e Giovanni, o, ancora per i Tiepolo, Giandomenico e Gianbattista. Tuttavia, già allora, io pensavo a qualche cosa di ancora diverso e l’unico esempio che mi veniva in mente era quello dei Bonichi. La loro era una famiglia artistica sui generis che si era tramandata la gioia dell’arte non per fare bottega, ma per passione ed impeto creativo. Poi di quell’idea non se ne fece nulla e adesso, invece, si può riprenderla felicemente per andare ad indagare quel fenomeno strano, geneticamente imparagonabile, che è, appunto, la famiglia Bonichi ed i suoi addentellati. Come ho appena ricordato, infatti, la Storia dell’Arte, quella con la “S” e con la “A” maiuscole, ci ha abituato a gruppi di famiglia che si sono passati il testimone consapevolmente, ovvero con l’intento di continuare le proprie cifre stilistiche per motivi di mestiere, magari raffinandole, adattandole alle più recenti esigenze, alle mode, oppure creando le mode attraverso di quelle. Diverso è il discorso se i membri di una stessa famiglia, a distanza di decenni, finiscono per ritrovarsi sul terreno dell’arte, quasi per caso e senza la volontà o lo scopo di tramandarsi nulla. È quanto accade alla famiglia Bonichi che annovera, fra i suoi componenti, stelle di prima grandezza della scena artistica italiana. Quella della famiglia Bonichi, infatti, è un’alchimia dell’arte e della genetica che può considerarsi più unica che rara perché nessuno di loro ha chiesto all’altro di continuare il percorso che era stato iniziato. Tutti, però, si sono ritrovati nella grande piazza dell’arte perché una voce – alla quale non hanno potuto resistere –, li ha chiamati, loro malgrado, a passare da lì per soffermarsi sulle necessità che derivano dai propri linguaggi creativi. Si è trattato di necessità ineludibili che hanno prodotto, in un’indagine a posteriori, la possibilità di rilevare quelle che vorrei definire “isoidi creative”, ossia tematiche ricorrenti nei vari percorsi pittorici che sono nate senza alcuna contaminazione consapevole. Allora questo breve studio, che qui presentiamo come mostra, serve anche a porre in evidenza questi aspetti singolari che possono, però, illuminare non soltanto le vicende di questa famiglia di pittori, ma anche le dinamiche della creatività umana.
I protagonisti. Se si avrà la pazienza di seguire le scattanti linee bianche (si veda p. ••) che legano fra loro i nomi tracciati fra i rami di un tronco ischeletrito che si trasforma per miracolo in rigoglioso albero genealogico, si vedrà che la vicenda di questa singolare storia familiare intreccia insieme l’Italia del nord e quella del centro in un percorso unico di arte e di storia. Le figure che emergono da questa successione di nodi d’amore hanno permesso la nascita di personaggi straordinari come Eso Peluzzi, Gino Bonichi, meglio noto come Scipione, Claudio Bonichi e Benedetta Bonichi che si sono passati il testimone dell’arte dal 1894 fino ad oggi. Il primo, in ordine di tempo, ad affacciarsi sulla scena del mondo è stato Eso Peluzzi, nato a Cairo Montenotte in Piemonte, da Giuseppe e Placida Rodino il 6 gennaio 1894. Il giovane Eso ha subito a che fare con la dimensione artistica perché il padre è un liutaio di grande abilità e la madre una delle prime fotografe italiane. Infatti, le intenzioni del ragazzo sono quelle d’iscriversi al conservatorio, ma poi decide per l’Accademia di Belle Arti Albertina di Torino che frequenta da quando aveva diciassette anni fino a quando ne compie ventuno. Qui è allievo di Cesare Ferro, di Paolo Gaidiano e Giacomo Grosso, quando l’Accademia non aveva solo professori, ma maestri che insegnavano a tagliare la vita con il cuore. Passata la tragedia della Prima Guerra mondiale, Peluzzi si stabilisce prima a Santuario di Savona e, poi, nel borgo di Monchiero, dove vive felicemente per tutto il resto della sua vita (si spense nel 1985) fino a meritarsi la cittadinanza onoraria. Ecco qui il suo pensiero in quell’occasione: <>. Il legame profondo con Monchiero non gli impedisce di viaggiare per l’Italia, di spostarsi a Como prima e poi ad Assisi per approdare a Roma nel 1928 e quindi a Parigi undici anni più tardi. Peluzzi è un pittore molto apprezzato negli anni della sua piena giovinezza e, perciò, gli commissionano nel 1927 la decorazione ad affresco della chiesa parrocchiale di Ellera e, un anno più tardi, quella del santuario di Nostra Signora della Misericordia a Savona e poi, dieci anni più tardi, la sala consiliare del Municipio della città ligure. Inoltre, è invitato a rassegne nazionali di alto livello come la Quadriennale di Torino, la Quadriennale di Roma, varie edizioni della Biennale di Venezia, grazie alle quali miete premi e riconoscimenti, a cominciare dalla medaglia d’oro dell’Albertina di Torino, fino al premio della seconda Quadriennale di Roma. Per questo straordinario percorso, nel 1963, è nominato Accademico di San Luca, uno dei massimi riconoscimenti nazionali, che derivava anche dalla cospicua attività all’estero che lo aveva visto protagonista di mostre personali nelle principali città europee e non solo come testimoniano gli eventi di Buenos Ayres e Baltimora.
Dal punto di vista della nostra storia, un momento cruciale nei nodi d’amore che si svilupparono lungo gli intrecci di quello straordinario albero genealogico da cui siamo partiti, fu lo sposalizio della figlia di Eso Peluzzi, Elsa, grazie al quale intrecciò la propria vita con quella di Agostino Bonichi, cugino di primo grado di Gino Bonichi, meglio noto come Scipione che, guarda caso, era nato in quello stesso 1904, quando Agostino aveva visto la luce. A differenza di Eso Peluzzi che visse per novantun anni, Gino Bonichi rimase su questa terra per soli ventinove; il che spiega l’esiguità della sua produzione. Gino Bonichi, detto Scipione nasce a Macerata il 25 febbraio del 1904, ma la sua esistenza è subito compromessa dalla malattia polmonare che lo insegue come un’ombra tremenda per tutto l’arco della sua breve vita. A metà degli anni Venti, la famiglia Bonichi, ossia Serafino il padre ed Emma Wülderk la madre, si trasferiscono a Roma insieme al figlio ventenne; risiedono al civico 190 di viale Cola di Rienzo, non lontano da San Pietro. È in questa casa che Gino ha l’incontro della sua vita, quando – convinto dai racconti di un comune compagno d’armi, all’indomani del suo congedo dal servizio militate – Mario Mafai viene a trovarlo e lo convince a seguire con lui le lezioni della Scuola Libera del Nudo, a Piazza Ferro di Cavallo, nell’emiciclo dell’Accademia di Belle Arti di Roma. Si tratta di un sodalizio concluso solo con la morte di Gino Bonichi, avvenuta nel 1933. Il rapporto è accresciuto dalla presenza di Antonietta Raphaël, compagna e moglie di Mario che ha in Bonichi un sodale con cui condivide una corrispondenza piena ed una totale affinità di vedute. Non è un caso che Mafai abbia scritto queste parole: <<… appoggiati l’uno all’altro, nutriti delle stesse idee, ci potevamo mischiare come un mazzo di carte per dirla con una sua frase.>>. Il sodalizio fra Mafai e Bonichi, cui si aggiungono poi, anche il giovane Capogrossi e Mazzacurati, dà origine alla “Scuola di via Cavour”, secondo la felice definizione che Roberto Longhi ricava dalla nuova residenza di Mario, dove si era domiciliato, dal 1927. Con Antonietta e la figlia Miriam, infatti, vivevano in un appartamento grande a poca distanza dal Colosseo. Non si ha vera e propria certezza documentaria su quale sia stata la prima mostra frequentata dai due pittori insieme, perché ci si deve affidare soltanto alla parola di Francesco Coco che ricorda di averli veduti alla III Biennale Romana Internazionale di Belle Arti, nel grande Palazzo delle Esposizioni a via Nazionale. È il 1925 e se non è in quest’occasione, è comunque in questo anno che Gino Bonichi si appropria dello pseudonimo che lo avrebbe reso celebre. È quello un periodo importante per l’artista che, in autunno, prende a frequentare i corsi della Scuola Libera del Nudo e poi, strette nuove amicizie, si diverte a girare per la città con i compagni di corso, cui si aggiunge, nel 1926, Renato Marino Mazzacurati. La distanza fra via Ripetta, dove si trova la Scuola Libera del Nudo, via Cavour, dove dal 1927 abita Mafai, e la grande Biblioteca di Storia dell’Arte di Palazzo Venezia, dove sta pure la sede del capo del Governo fascista, è piuttosto piccola ed allora, viene quasi naturale per i due artisti in erba lasciarsi andare alla ricerca fra i polverosi libri di quella cittadella della cultura. L’austero palazzo voluto dal cardinal Pietro Barbo, poi papa Paolo II, che aveva subito da poco lo spostamento del viridarium con la conseguente creazione della nuova piazza, ospitava – allora come oggi – una delle più aggiornate e importanti biblioteche italiane dedicate all’archeologia ed alla storia dell’arte. Scipione e Mafai si trovano come i topi nel formaggio, felici di approfondire la conoscenza di pittori più o meno famosi, da Velázquez a Goya, da Piero della Francesca a Brueghel, ma anche contemporanei, come Kokoschka e Chagall, a dimostrazione che ogni grande artista deve essere anche uno storico dell’arte. Il 1927, però, è un anno pesante per Scipione. Mentre Mafai si trasferisce a via Cavour con la famiglia, Gino è costretto a ricoverarsi in sanatorio. Questo riposo forzato è un lungo momento di meditazione documentato dalle lettere all’amico catanese Mario Mimì Lazzaro cui consegna parole di grande tristezza: <>. Scipione, però, non si abbatte e, sostenuto da una volontà ferrea, riprende a dipingere lottando contro la malattia che lo mina con frequenti ricadute. La critica dell’epoca gli riserva una certa attenzione e diverse sono le occasioni che gli si presentano per esporre le proprie opere, a cominciare dalla mostra collettiva indetta dal “Convegno di Roma”, per continuare con quella organizzata dal “Sindacato Fascista”. In estate, per curarsi, si trasferisce a Collepardo, un paesino di montagna, non lontano da Guarcino, in Ciociaria, dove c’è l’aria buona. L’anno si conclude con la III Mostra Marinara a Palazzo delle Esposizioni, accanto all’amico Mafai. I riconoscimenti della critica si susseguono e le occasioni per esporre si moltiplicano fino alla Biennale di Venezia del 1930, dove gli viene assegnato il “Premio Gioventù”, grazie alla lungimiranza di una giuria altamente qualificata, presieduta da Adolfo Wildt, che vedeva fra i suoi membri artisti come Felice Carena e Cipriano Efisio Oppo che lo aveva già notato negli anni precedenti. Qui Scipione aveva presentato uno dei suoi capolavori, Il Cardinal decano, figlio di sicuro della riflessione sull’Innocenzo X di Velázquez ed antesignano delle opere di Bacon, delle quali anticipa, con una grazia sottile, la critica al potere che l’artista inglese, però, descriverà come un disfacimento violento, ben lontano dall’intima meditazione di Bonichi. Tuttavia, Oppo, non andò lontano dal vero quando, in quell’occasione, scrisse del quadro: <>. Il legame della pittura di Scipione è con la grande arte europea degli Ensor, dei Kokoschka, dei Soutine, dei De Pisis, ma con una vena più interiorizzata e sensuale che sfugge agli altri maestri. Scrivono di lui Corrado Pavolini, Guglielmo Usellini, Lionello Venturi e Orazio Amato. Stremato dalla fatica, Scipione si rifugia nuovamente a Collepardo, ma i problemi economici lo inducono ad intensificare l’attività d’illustratore per la rivista l’Italia letteraria. A fine anno, s’inaugura nella capitale, presso la “Galleria di Roma”, la mostra Scipione e Mafai, atto di nascita ufficiale della Scuola Romana e considerata da Libero de Libero <<…un vero uragano nel cielo artistico di Roma.>>. Scipione, intanto, continua la sua attività di illustratore e nel gennaio del 1931, viene invitato alla prima edizione della Quadriennale d’Arte Nazionale allestita presso le maestose sale del Palazzo delle Esposizioni e presieduta da Cipriano Efisio Oppo. Si tratta di un evento di livello nazionale ed internazionale che sancisce il ruolo dell’Italia nel panorama artistico europeo, con una retrospettiva su Medardo Rosso e opere di Carena, Carrà, Casorati, Ferrazzi, Sironi e Soffici, tanto per ricordare i principali. Non tutta la critica è unanime su Scipione, però: si teme il suo calligrafismo, la scarsa consistenza plastica, senza capire del tutto che proprio quella è la sua forza e il suo metro interiore, figlio anche della malattia che lo attanaglia. Alla fine del 1931, lo capiscono invece gli Americani perché una sua opera – l’Apocalisse – viene esposta a Baltimora nell’ambito della Exibition of Contemporary Italian Paintings curata da Ronald J. Mc Kenney. Scipione non si può neppure godere a pieno quei momenti perché la malattia lo costringe ad un altro ricovero in sanatorio e poi, di nuovo alla ricerca di aria pura, si rifugia questa volta ad Arco, in Trentino, dove l’artista sembra recuperare in pieno le proprie forze. Nel frattempo, continua la sua attività grafica e, sebbene si diradi la presenza sulle pagine de L’Italia letteraria, illustra la copertina della raccolta di poesie di Eugenio Montale intitolata Ossi di seppia e due suoi disegni vengono pubblicati rispettivamente sull’Almanacco degli artisti. Il vero Giotto 1932 e sull’Almanacco letterario. All’inizio del 1932, un’altra opera, Paysage, è presentata a Parigi in una collettiva dedicata a ventidue artisti italiani, fra cui Campigli, Carrà, De Chirico, Morandi e Sironi, tanto per citarne alcuni. Da Arco, Scipione torna a Roma e si stabilisce nella nuova casa dei genitori a via di Forte Trionfale, dove riprende la sua attività d’illustratore. Purtroppo, però, nei primi mesi del 1933 è costretto a tornare ad Arco per tentare di curarsi. Il soggiorno sembra sortire l’effetto desiderato e torna a Roma, ma ad aprile si ammala di nuovo e si sottopone ad un intervento chirurgico ai polmoni che, però, non sembra dare il risultato sperato e quindi torna di nuovo ad Arco per curarsi con l’aria buona, dopo l’estate. Scrive: <>. Nel novembre di quell’anno, però, Scipione, si spegne nel sanatorio di Arco consegnando le sue opere all’eternità dell’arte. Gino Bonichi, non lascia figli se non gli altri pittori che si considerano suoi eredi culturali ed artistici i quali guardano a lui come ad una figura di spicco della Scuola Romana.
Così, i rami del nostro albero genealogico, avrebbero cessato di crescere e germogliare se si fossero dovuti affidare solo alla presenza e all’azione di Gino Bonichi, ma non fu così ed è questo, come vedremo, che rende interessante la nostra indagine perché nei temi che andremo ad esaminare più avanti, faranno la loro comparsa contaminazioni inaspettate che proprio da Scipione derivano o a lui s’ispirano senza alcuna consapevolezza diretta.
I rami dell’albero, infatti, si arricchirono di un altro nodo d’amore con la nascita di Claudio Bonichi, figlio di Agostino, a sua volta figlio di Benedetto, che era fratello di Serafino, padre di Gino, il grande Scipione. Agostino, che come s’è detto aveva sposato Elsa Peluzzi, era un ufficiale d’aviazione che aveva solcato i cieli prima della Seconda Guerra Mondiale ma che, nel corso del conflitto, fu impiegato a terra. Eroe della resistenza, rischiò la vita per aver fatto saltare in aria il deposito che comandava. Consegnatosi ai Tedeschi per non scatenare rappresaglie, riuscì a fuggire poche ore prima che lo fucilassero. Quando accadde, Claudio non era ancora nato, ed Agostino visse per qualche tempo alla macchia.
Claudio Bonichi nasce il 4 giugno del 1943 in Piemonte, a Novi Ligure, ad una ventina di chilometri da Alessandria. Qui, però, rimane poco tempo perché la sua famiglia è costretta a scappare, inseguita dai Tedeschi che non avevano certo gradito l’azione di guerriglia di cui Agostino era stato protagonista. Tuttavia, a prescindere da questo episodio, lo spostamento da una città all’altra, sarà una costante nella prima infanzia del piccolo Claudio, detto “Dodo”, che, per il particolare mestiere del padre, sarà costretto a viaggiare per tutta Italia. La residenza degli anni della guerra, sarà Montechiaro d’Acqui, nella medesima regione, poi sarà la volta di Savona e, poi, ancora, si sposteranno ad Anzio. La scelta del mare era un atto d’amore, per irrobustire la salute del piccolo Claudio, ma anche per soddisfare la passione di Agostino che era stato pure Comandante di Marina. Per questo arrivano a Taranto, dove rimangono tre anni. <>. Così si confesserà, da grande, Claudio Bonichi. Il piccolo Dodo scopre il gusto di disegnare da subito: a Savona, nel 1948, partecipa addirittura a un Premio delle Arti e rafforza il legame con il nonno Eso che fotografa le lavagnette disegnate con il gesso da quel bimbo di tre anni. Così, da grande, lo ricorda in un’intervista del 1990, raccolta da Maurizio Fagiolo dell’Arco: <>.
La prima mostra personale di Claudio Bonichi risale al 1964. Claudio ha solo vent’un anni e, in tasca, una lettera di Fortunato Bellonzi che sembra quella di un padre premuroso più che la presentazione di un importante critico d’arte. Ad avergli organizzato l’esposizione è stato nonno Eso che voleva forzarlo sulla via dell’arte perché ne apprezzava già le doti. Qui, in una galleria di Alessandria, Bonichi espone una dozzina di tele ed una quindicina d’incisioni su linoleum che furono molto apprezzate da Maccari, allora titolare della cattedra d’incisione presso l’Accademia di Belle Arti di Roma. L’abilità grafica del giovane artista viene ben presto notata da Mario Fògola, il libraio di piazza Carlo Felice a Torino che, in quel lontano 1966, non era certo soltanto un venditore, ma un intellettuale attento alle novità artistiche, nonché titolare della Dantesca Galleria, dove Bonichi esporrà una dozzina di anni più tardi. Per questo lo propone come illustratore dei Vangeli, nonché della serie dedicata alle Tavole incantate di Angela Belidi (ovvero menù di fantasia) e, ancora, del Candide di Voltaire. Nel 1970 è la volta della mostra di Portofino, Children’s Corner, dove espone acquarelli nei quali sono i giocattoli ad essere frammenti di un diario d’infanzia non scritto che affiorano come oggetti archeologici nel deserto della memoria. Il tema del deserto ritorna in Nostra Signora del Deserto, dove una donna al limite della blasfemia, s’immola sul bordo dei ricordi di una fanciullezza trascorsa. Il decennio fra il ’70 e l’80 del secolo scorso è impiegato da Claudio Bonichi per individuare temi e tecnica. I primi sono la memoria e i giocattoli, con certe concessioni alla figura, come In morte di una signora, mentre la seconda viene messa a punto con certosino impegno e l’attenzione costante ad un equilibrio tonale che si gioca su mezzi cromatici volutamente limitati e su una materia povera, ma evocativa al tempo stesso. I picchi d’eccellenza di questo decennio sono, da una parte, la mostra del 1978 a Torino, nella Galleria di Mario Fògola, dove compare per la prima volta il tema della natura morta e, dall’altra, l’esposizione del 1979 presso la Galleria Trentadue di Milano che ebbe grande eco sulla stampa, con recensioni di Paolo Levi, Cavazzini e Villani su Bolaffi Arte. Gli anni Ottanta sono un momento cruciale nel percorso artistico di Claudio Bonichi, per via dell’incontro con Alfredo Paglione, che lo ospita ancora a Milano nella Galleria Trentadue nel 1982, presentato da Giovanni Arpino. Nel 1984, poi, espone a San Severa, nell’isola di Mallorca, presso la Galleria Sa Pleta Freda, con la presentazione di Baltasar Porcel che, in quell’occasione, scrive: <>. Come dire che gli occhi di Caludio Bonichi sanno scoprire la bellezza ovunque e sanno scovare l’armonia della divina proporzione in qualunque cosa passi sotto il suo sguardo <<…in una pera, in una fanciulla, nei petali dei fiori.>>. Dura oltre vent’anni la collaborazione con Alfredo Paglione, grazie alla quale sono inanellate una serie di mostre importanti fra cui non si possono non ricordare La vita è sogno nella Galleria Appiani di Milano (1999), El Teatro de la Memoria nella Galleria Juan Gris (2002) e Natures Mortes nella Galleria Artur Ramón a Bracellona (2002). Del resto, già da tempo, s’interessavano di Claudio Bonichi critici di tutto rispetto come Giovanni Testori, Antonello Trombadori, Giorgio Soavi, Vittorio Sgarbi, Dario Micacchi, Mario De Micheli, Giorgio Mascherpa. Le mostre si moltiplicano con esposizioni a Roma, ad Amburgo, ancora a Milano, presentato nel 1987 da Maurizio Fagiolo dell’Arco e poi le importanti retrospettive in Spagna, Olanda, Danimarca, Canada, Giappone, Germania, Francia, Belgio. Nel 2006, per i cento anni dalla nascita di Luchino Visconti, realizza la mostra La Casa dei Giochi (Ischia, Fondazione la Colombaia) e, nello stesso anno, a Barcellona Renata ante el Mirall, nella Galleria Toc’D’Art. Partecipa poi alla mostra itinerante Mythos per il Ministero degli Esteri, che tocca Atene, Cipro, Tirana, Montecarlo. Nel 2007 presenta a Franca villa al Mare, presso il Museo Michetti la mostra Oltre l’oggetto; nel 2008 Visconti e il contemporaneo a Napoli, al Maschio Angioino e nel 2009 L’essenza invisibile al Museo Nazionale di Palazzo Lanfranchi di Matera.
L’ultimo nodo d’amore del nostro albero genealogico, in ordine di tempo, è Benedetta Bonichi che non aveva nessuna intenzione di dedicarsi alla pittura o all’arte, ma aveva intrapreso un percorso di studio e di ricerca.
Benedetta Bonichi, nasce ad Alba da Claudio e da Mariapia De Luca, nel cuore delle Langhe, il 4 agosto del 1968, prima di altre due sorelle, Marta e Chiara e di un fratello, Francesco. Benedetta è una ragazzina esile, dai lunghi capelli biondi che, non di rado, si diverte a scarabocchiare sui fogli nello studio del padre, mentre importanti critici d’arte vengono a trovarlo per vedere i suoi quadri. Tuttavia, nulla è più lontano dalla mente di Benedetta che l’idea di dedicarsi alla pittura. Dopo gli studi classici prosegue con l’università iscrivendosi a “La Sapienza” di Roma presso la facoltà di Lettere e Filosofia dove s’interessa però di antropologia ed anche di biologia. A vent’anni legge L’altra faccia dello specchio di Konrad Lorenz. È come una folgorazione e Benedetta inizia a scrivere freneticamente. Attraverso il presidente della Società Italiana di Microbiologia, entra in contatto con la Scuola di Antropologia Umana della facoltà di Biologia dell’università di Firenze. Tuttavia, il corso di studi non soddisfa il suo animo inquieto e nel 1991 lascia l’università. Da quell’anno fino al 1995 si occupa di musica, danza, mimo, apre un’agenzia teatrale e inizia a disegnare e a dipingere, ma smette di scrivere. Nel 1995 legge per caso To see in the dark, un articolo pubblicato in Germania nel 1934, da cui prenderà il titolo della principale opera del suo nuovo corso. Dal 1995 al 1997 realizza una cinquantina di sculture, come dice lei <>. Più che di opere vere e proprie, si tratta d’impronte che sembrano lasciate da fantasmi su tele già tese, modellate quasi da una forza interiore, come in Myself del 1997, dove il volto dell’artista, a mo’ di bassorilievo, forgia il gesso che copre la tela trattata con vari materiali; oppure sono involucri di stoffa che lasciano intuire la forma vuota. Nel 1999, dopo vari tentativi, realizza le prime radiografie. In origine, si trattava di mettere in posa quei manichini di plastica usati dagli studenti e dai professori di Anatomia Artistica che riproducono lo scheletro umano. Si provvedeva, così, ad atteggiarli in pose e situazioni varie per poi fotografarli e trasformarli in radiografie. Il teatro di posa, infatti, è l’Accademia di Belle Arti di Roma dove Benedetta si reca grazie all’ aiuto ed alla complicità artistica di pittori e artisti amici. Questa tecnica, però, non la soddisfa del tutto e cambia: utilizza radiografie vere che poi elabora elettronicamente e stampa su tela o su carta preparata ai sali d’argento e che, infine, ritocca e modifica per avere l’effetto voluto; oppure utilizza fogli di alluminio. Nasce, così la serie di opere che verrà esposta, dall’11 luglio al 1° settembre del 2002, presso la Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Arezzo, con il titolo To see in the dark, <>. La mostra è dedicata a Maurizio Fagiolo dell’Arco, morto poco prima della inaugurazione, che l’aveva presentata a Giovanni Faccenda, direttore della Galleria. Fagiolo dell’Arco, scomparso prematuramente, aveva veduto le opere di Benedetta nello studio di Claudio ed aveva dovuto lottare contro la ritrosia della giovane artista che non aveva alcuna intenzione di esporle al pubblico. La simpatia e l’acume di Faccenda, però, fanno breccia nella riservatezza di Benedetta e si allestisce la mostra con un bel catalogo che a me, ignaro di tutto, viene recapitato per posta. All’inizio è solo uno dei vari cataloghi che mi arrivano a casa, insieme agli inviti per le mostre, elettronici o cartacei. Poi, però, quando apro la busta e comincio a guardare le opere, resto affascinato e decido di scrivere una lettera a Benedetta che cominciava più o meno così: <>. Naturalmente, non possedevo l’indirizzo dello studio di Benedetta e, quindi, spedisco la lettera alla Galleria d’Arte Contemporanea di Arezzo. Passano i mesi ed io mi dimentico del catalogo e della lettera, quando mi arriva la risposta datata 15 ottobre del 2005, il cui testo riporto in buona parte perché è l’inizio di un’amicizia e di una collaborazione di cui questo scritto è il segmento più recente: <>. Quell’anno ero intento a scrivere Il corpo umano. Anatomia e significati simbolici, uno dei <> edito da Electa, che è stato tradotto in Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo. Non era possibile, allora, evitare di fare un riferimento a Benedetta, di cui pubblico (p. 335) la Donna che si pettina, un’opera del 1999 che rimanda all’antica bellezza di Elena di Troia nell’immaginifica scoperta di Heinrich Schliemann; o per lo meno questo è quel che mi ha suggerito e, forse, non ho neanche scritto. Fatto sta che l’attività artistica di Benedetta, le procura la Targa d’Argento del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e le si presenta la possibilità di partecipare alle prime mostre internazionali, sicché – da adesso – espone stabilmente a Vienna, Cipro, Parigi, San Paolo del Brasile, Mosca ed Atene. Nell’ambito delle iniziative dell’Accademia di Belle Arti di Roma che, allora, allestiva una rassegna intitolata “Arte in terrazza”, organizzo una personale dell’artista e, nello stesso 2006, scrivo, insieme a Giorgio Soavi, la presentazione alla mostra presso la Galleria Tondinelli di Roma e la sede dell’Istituto Italiano di Cultura a New York, allora diretto da Claudio Angelini il quale dedica una poesia al grande Banchetto di Nozze che Benedetta aveva esposto nel 2003 a San Paolo del Brasile, presso il MAC dell’Università, con presentazioni di Achille Bonito Oliva, Elza Ajzeneberg, direttore del MAC e Baltasar Porcel. Così, scrive Angelini: <>. Non solo, ma Benedetta si sperimenta come regista in una serie d’interviste filmate che s’intitolano emblematicamente Interiors caratterizzate dal fatto che i personaggi coinvolti si confessano, ma parlano sotto l’effetto dei raggi x. Così, Carlo Lizzani, Pietro Piovani e Giuseppe Scalera, parlano di loro stessi, della loro vita, mostrando quanto di più intimo sia possibile immaginare, ovvero la struttura scheletrica che, però, si muove e racconta contraddicendo di fatto il messaggio semantico che lo scheletro in genere comunica. Dal 2007 espone stabilmente allo spazio Thetis per la Biennale di Venezia, all’Armory Show di New York, al Preview Art Fair di Berlino e alla International Art Show di Miami. Le sue opere figurano in pubblicazioni d’arte, scientifiche ed accademiche – in gran parte – internazionali e nelle collezioni permanenti dei musei MAC (San Paolo), MACRO (Roma), la Pharos Trust Foundation (Cipro), il Museo Wilfred Lam (La Habana). Alcune opere, inoltre, hanno ispirato stilisti, coreografi e scrittori quali Carolyn Carlson, Jacopo Etro, Christian Loboutin, Pablo Armando Fernandez, Baltasar Porcel, Tiziano Scarpa, Marcelle Padovani e Giorgio Soavi. Nel 2011 lo scenografo Philippe Decouflé ha scelto i lavori di Benedetta Bonichi per la sua ultima tournée che, in tre anni, toccherà ben 19 paesi europei e, poi, si trasferirà in Giappone e negli Stati Uniti.
I temi. Da questa ricognizione necessariamente sommaria, emergono aspetti che confermano la singolarità di quella che potremmo definire la “bottega Bonichi”. Il passaggio del testimone dall’uno all’altro dei vari protagonisti, infatti, non segue i canoni della bottega artistica che la tradizione ci ha consegnato, come potrebbe essere quella dei Della Robbia o dei Parler, la famiglia di architetti e scultori d’origine renana che fu attiva in Germania prima di tutto, ma anche in Ungheria, in Austria, in Boemia e in Italia. La caratteristica di queste botteghe era quella di formare i giovani artisti della famiglia cui veniva insegnato a mantenere l’impronta stilistica che aveva fatto grande la bottega, che le aveva aperto il successo di mercato. Stava poi all’abilità del singolo, modulare le novità stilistiche in funzione dei cambiamenti di gusto; poi, quando le condizioni mutavano radicalmente per motivi diversi – che potevano andare dall’ingresso di nuove conoscenze o di nuove tecnologie o, più semplicemente, di nuove mode –, la bottega, se non era in grado di aggiornarsi, chiudeva. Il caso dei Bonichi è assai diverso perché non parte da questi presupposti, non è finalizzato ad obiettivi di mercato, ma si basa sul riproporsi di un’esigenza interiore che, in qualche caso, come quello di Benedetta, non emerse da subito, ma si presentò in un’età ben più avanzata di quella cui generalmente erano destinata i rampolli delle grandi famiglie artistiche. Questa diversità ha prodotto un fenomeno molto singolare perché percorsi congruenti sono nati da esigenze, epoche e sensibilità diverse che, però, paiono guidate da una coscienza comune emersa in maniera spontanea e solo più tardi ricostruita a posteriori. Per questo, adesso, per dare consistenza a queste informazioni, si rende necessaria e piacevole una ricognizione sui temi che si sono intrecciati in questo secolo di creatività firmato Bonichi. Bisogna infatti chiedersi perché artisti così diversi fra loro, distanti nel tempo e, talora, nello spazio – anche se legati da un saldo legame di sangue – si sono ritrovati su argomenti visivi identici, che emergono nell’animo di ciascuno di loro e vengono poi, con le diverse modulazioni, interpretati nelle varie opere.
Gli amanti impossibili. L’obiezione che potrebbe nascere spontanea dall’esame di questo primo esempio di “isoidi creative”, potrebbe essere quella di una scelta tanto scontata quanto ovvia, visto che riguarda l’amore, un tema che appartiene alla quasi totalità dei mondi poetici degli artisti di ogni secolo. Tuttavia, quel che emerge dalla realtà lirica di questa famiglia di artisti è la difficoltà dell’amoroso modo, ovvero la fatica del rapporto a due che non si presenta come un idillio, ma come una frattura nel discorso. Gli amanti impossibili sono tali perché non comunicano fra loro. Anche se si abbracciano, non si aprono l’uno all’altra perché non c’è relazione, nel senso che non si guardano, oppure mancano le condizioni stesse per l’atto amoroso.
Si prenda in esame, per esempio, Figure di Scipione, pubblicato per la prima volta sul numero di marzo de <<L’Italia letteraria>> del 1932. I personaggi sono più di due, ma i protagonisti sono quelli in primo piano, indiscutibilmente. Lei è immersa nell’ombra bituminosa, lui è inondato di luce e con fare galante e misurato, prende la mano di lei. Sono nudi, sembra che si debbano abbracciare da un momento all’altro, ma in realtà non si guardano nemmeno. Entrambi alzano lo sguardo verso l’alto e ciascuno osserva un punto diverso: i loro occhi non s’incontreranno mai. Non c’è intesa fra loro: amarsi è impossibile. Il tratto grafico di Scipione non fa che amplificare quest’ansia da incomunicabilità che si aggomitola e si arrovella sui segni lasciati dalla penna, addensati dal pennello nel nero di un inchiostro che non è troppo diverso dal buio dell’anima. Insomma, siamo già alla fine prima di cominciare.
Allora subito emerge dalla memoria la diafana immagine de Il bacio di Benedetta Bonichi, realizzata nell’anno 2000 su carta preparata a sali d’argento. Il bacio è il sigillo del rapporto d’amore, ma anche il seme dal quale germoglia il desiderio e la passione per l’altro che è la gioia della vita; una vita che qui, con la radiografia è osservata in controluce, in filigrana, percependone tutta la fragilità. Non per nulla, spiega la Bonichi: <>. Anche questo è un amore impossibile, già minato dalla prospettiva del suo divenire, negazione del suo essere bacio. Scrive ancora l’artista: <>. Una fantasia iconografica che assimila gli amanti ad una pianta con due tronchi che s’intrecciano, nati dalla stessa radice, che è quella dell’incastro del sesso; un tema su cui Benedetta ritorna di recente con due opere: La conversazione platonica e La Recherche. Nella prima gli scheletri si conficcano l’uno nell’altro come gli innesti di legno di una costruzione a capriata di un edificio sacro che è quello dell’esistenza. Un arto sopra l’altro e il sesso inesistente che è già pronto a chiudere il cerchio di un’unità da ricostruire sulle ceneri dei propri sentimenti. Nella seconda, un’esplorazione proustiana alla ricerca dell’Origine del mondo come direbbe un Courbet diviso fra due sessi. Un’indagine tanto scrupolosa quanto inutile, nella quale occhi vuoti sbirciano l’impossibile radice di una vita consunta e inaridita, squassata da un vento d’amore ridotto a polvere dal passare dei secoli e delle ere geologiche. Un frammento della Pompei dell’anima, raggela il calco incredibile degli amanti archeologici uniti per sempre nella ricerca frustrante di se stessi.
Ancora una volta, perciò, amanti impossibili, che pur vicini l’uno all’altra non si possono incontrare, come I manichini di Claudio Bonichi: abbracciati, ma non uniti. È un olio su una grande tela di formato quadrato realizzato nel 1976. Il deserto dello sfondo è certo metafora di quello che si estende nell’animo dell’artista, abitato dalla inquietante presenza di due manichini nudi che si tendono le braccia l’un l’altro in un rigido e inanimato gesto amoroso. A nulla servono i grandi occhi lucidi di vetro che non sanno restituire la vita ai due amanti senza respiro. Come nel caso di Scipione, gli sguardi non s’incontrano, ma a differenza di quel disegno che evocava persone vere, qui non potranno incontrarsi mai perché di quelle c’è solo il simulacro. Eppure, l’idea c’è; quella dell’amore che mette insieme le due metà del cielo, le due metà della mela, verrebbe da dire, che insieme danno origine all’unità. Un’unità che, però, nel mondo poetico di Claudio Bonichi, spesso, si spezza come dimostra un altro quadro che rappresenta, appunto, una mela tagliata, metafora – di nuovo – degli amanti impossibili. Chi sono gli amanti impossibili ? Sono quelli che non s’incontreranno mai, né oggi né mai; perché le due metà della mela, in quanto tali, non sono più l’unità, come immagini riflesse nello specchio impossibili da ricongiungere, anche se si somigliano come due gocce d’acqua; in realtà sono maschere, l’una il simulacro dell’altra. Quelle dipinte da Claudio Bonichi sembrano vivere di vita propria e, allora, paiono amarsi, ma non è vero perché la loro è solo apparenza. Dietro, c’è il vuoto.
Infine, non possiamo non ricordare Eso Peluzzi, che non si è mai abbandonato a questo tema, ma che pure ne ha vissuto il riflesso per metafora prendendo in considerazione l’episodio biblico di Susanna, rivisitato in chiave laica in un disegno di poco posteriore. La storia è nota ed è narrata nel XIII capitolo del Libro di Daniele. Il protagonista è di nuovo lo sguardo e l’impossibilità di comunicare. Due ricchi ed attempati possidenti s’intrufolano varie volte nel giardino di Susanna per sbirciare le belle nudità della fanciulla quando si fa il bagno all’aperto. Una volta, però, decidono di forzare la mano e quando le ancelle si allontanano si fanno avanti per molestarla. Naturalmente Susanna si difende e quando le ancelle tornano, chiamano gente per accusare la giovane di essersi macchiata d’adulterio con un ragazzo poi fuggito. Susanna è condannata alla lapidazione, ma lei si professa innocente e chiede aiuto a Dio. Interviene allora Daniele che invita gli astanti a sentire i due vecchi separatamente. Il loro racconto non coincide; si contraddicono dimostrando così l’innocenza di Susanna che viene scagionata, mentre i due sono condannati a morte. Peluzzi, come tutti i pittori che hanno affrontato questo tema, si ferma alla scena degli sguardi lubrichi sul giovane corpo della donna e dipinge la sua Susanna nel 1929. Naturalmente, la giovane volge la schiena agli amanti impossibili di questo racconto e sembra raggomitolarsi su se stessa. Qui l’idea dell’amore è offesa nel profondo per via dell’inganno che pervade tutta la scena. Gli sguardi dei tre protagonisti non potranno incontrarsi mai: nessuno potrà sostenere quello dell’altro. Di tutte le possibili scene d’amore che l’artista poteva immaginare, Peluzzi sceglie questo episodio che, ben al di là della dimensione morale, diviene la metafora della menzogna, di per sé, vera e propria negazione dell’amore se questo vuol dire donare se stesso all’altro. La versione laica della scena ritorna in un suo Disegno senza titolo più o meno dello stesso periodo, dove due gaudenti con tanto di tuba in testa (uno di loro) si beano delle grazie di una giovane donna che nel bel mezzo di un prato, all’ombra di un albero, si asciuga dopo essere uscita dalle acque di un ruscello o di un laghetto. L’opera è fresca; un acquarello schizzato rapidamente in punta di pennello che ritorna sullo stesso tema quasi senza volerlo: la distanza degli affetti e l’inadeguatezza del rapporto. Forse loro sì, potranno baciarsi e abbracciarsi, ma sarà comunque un amore impossibile, destinato ad esaurirsi nel piacere di un incontro fugace dove l’idea stessa del sentimento è negata dall’approccio truffaldino di chi ruba con lo sguardo il desiderio del corpo. Amanti sbagliati in ogni caso.
Gli amanti impossibili, però, sono anche coloro che prediligono la pratica dell’onanismo. Scipione affronta più di una volta questo tema, ma con I masturbatori del 1930, riflette insieme e con misura, sulla dimensione maschile e femminile di quest’abitudine sessuale. Alla scabrosità del soggetto, l’artista risponde con la levità e l’ironia di un disegno eseguito ad inchiostro in punta di penna dove un uomo ed una donna, invece di abbandonarsi ad effusioni reciproche, si dedicano a questo succedaneo dell’amore. Ognuno dei due è isolato nel proprio piacere, egoistico e sterile che li rende irrimediabilmente amanti impossibili. Siamo in un salotto, forse quello di una “casa chiusa” o di “tolleranza”, come si usava allora. Sullo sfondo ci sono le sedie, un calendario, un attaccapanni con un cappotto che deve essere quello dell’uomo di spalle. Questi è in piedi su un tappeto rialzato, è basso, mingherlino, piccolo davanti alla maestosa opulenza della donna che ha voluto incontrare, guardare e non amare mai. L’amore ha fatto cortocircuito, il donarsi all’altro si è rappreso in se stesso, ognuno si basta da sé, come le donne di Claudio Bonichi, disegnate nel 1992, di cui una porta sul viso una maschera perché l’artista sa bene che quel tipo di amore è un falso. Diverso è il discorso per Benedetta Bonichi e per il suo Stabat mater dove nulla c’è di blasfemo, perché la mater è la terra, la Grande Femmina che danza il canto della vita. Le sue ossa sono i monti, che la radiografia esalta. Si muove sinuosa, si sfiora con le mani come la brezza del mare sferza le montagne e vive il piacere dell’esistenza. È colei che è e che sempre sarà; sempre incinta anche se non sempre lo palesa, gode il respiro del mondo perché basta a se stessa. È l’amante impossibile perché nessuno potrà mai amarla, madre di se stessa e del cosmo, è l’eterno femminino per il quale il maschile è un pleonasmo.
L’ultima declinazione dell’amore impossibile è quella dell’ermafrodito a cui tutti, salvo Peluzzi, dedicano la loro attenzione. La mitica storia di Ermafrodito, è narrata da Ovidio nel libro IV delle Metamorfosi (vv. 390 ss.). Come rammenta il nome, Ermafrodito nacque dall’unione di Ermes e Afrodite, ma la sua vicenda amorosa è con la ninfa Salmace con cui si abbandonò ad un abbraccio talmente profondo da fondersi con lei in un unico corpo che manteneva intatte le caratteristiche sessuali maschili e femminili primarie e secondarie. Questa doppia natura di Ermafrodito fu interpretata da filosofi ed alchimisti come metafora dell’indistinto – quindi anche del diavolo come essere disordinato – ma pure della perfetta unità. L’interpretazione grafica che ne dà Scipione, però, è diversa giacché si accontenta della perversa bellezza di quello che a Napoli si chiamerebbe “femminello” cui aggiunge l’impertinente sonorità di un peto, confuso fra i tratti d’inchiostro di chi grida, anche in questo modo, la propria diversità giocosa e si traveste da donna pur essendo uomo. Allora l’Ermafrodito di Scipione, disegnato nel 1931, è quasi un Bagatto del desiderio che ironizza sull’impossibilità dell’amore perché i protagonisti si trovano nello stesso corpo. Dalla cappelliera che ha vicino, estrae scarpe col tacco a spillo, piume, fiocchi, corsetti, reggiseni che divengono oggetti e segni del sogno di chi vorrebbe essere e non può mai del tutto. Più malinconico è l’Hermes protettore delle città, dipinto da Claudio Bonichi nel 1980, che sembra alludere alla radice filosofica del tema, pur in una dimensione anatomica che lo avvicina al transessuale, moderna quanto impropria interpretazione dell’Ermafrodito. Qui Ermes / Mercurio è ermafrodito lui stesso, maschio e femmina al medesimo tempo, come dimostra il segno astronomico ed astrologico del pianeta, nel quale convivono il sole e la luna (ovvero il maschile e il femminile) sopra la croce degli elementi. Diversamente dalla scelta di Scipione, qui l’artista abbandona l’allegria dell’altro Ermafrodito, anche se il riferimento al gioco è presente, per via dei ninnoli che tiene in mano e la testa del cavalluccio sistemata in cima ad un’asta di legno infissa a terra. È il destriero preferito da tutti i bambini, quello che può essere qualsiasi cavalcatura per correre lungo i lidi della fantasia o per attraversare a spron battuto le strade di una di quelle città di cui l’Hermes di Bonichi è protettore. Un Hermes-ermafrodito triste, con la faccia della luna, sporca di farina, ben conscio del suo ruolo di amante impossibile. Un ruolo d’insoddisfazione come quello che trapela da un’altra opera di Benedetta Bonichi: Al Ben (fusione di due corpi). Non si tratta di un vero e proprio Ermafrodito perché si tratta di due scheletri, anche se la loro posizione pone l’accento proprio sul punto cruciale del mitico personaggio. Posti uno sull’altro, entrambi espongono il pube e l’ischio agli occhi di chi guarda. In tal modo è come se presentassero il sesso di entrambi come se fosse una carta da gioco, maschile in alto e femminile in basso o viceversa, poco importa. Quel che risulta interessante per noi, è che, come per un ermafrodita, la duplice natura sessuale sembra fondersi in una terza, diversa condizione, quella che trasforma due individui in uno solo decretandone, per l’ennesima volta, l’impossibilità di amare e di farsi amare.
Come si vede, di tutte le possibili chiavi di lettura di quell’immenso universo culturale, artistico ed iconografico che è l’amore, i nostri artisti, indipendentemente l’uno dall’altro, indagano solo quello della difficoltà o, addirittura, dell’impossibilità ad attuarsi. Si tratta della coincidenza di processi creativi diversi, ma paralleli fra loro, che si indirizzano verso agglomerati di sensibilità comune. È certo assai singolare che degli aspetti romantici, erotici, passionali, pornografici e sentimentali dell’amore, quelli presi in considerazione abbiano come denominatore comune, la sofferenza e la difficoltà esistenziale a raggiungere l’armonia e l’appagamento.
Tuttavia, non è solo questo degli “amanti impossibili” l’unico percorso creativo che coinvolga con uguale intensità i protagonisti di questa nostra, sia pur sommaria, disamina. Un altro tema importante, infatti, è quello dell’immagine del cardinale, considerata come l’altra faccia del potere, quella più odiosa perché finisce per configurarsi come una contraddizione in termini. È così che la intese Scipione, e sull’onda del grande Gino Bonichi, anche gli altri pittori della famiglia.
I cardinali. È ben noto che fu proprio il Ritratto del Cardinal Decano l’opera più famosa di Scipione (Roma, Galleria Comunale d’Arte Moderna), fin dalla sua comparsa sulla scena artistica non solo romana, visto che venne esposta nella XVII edizione della Biennale di Venezia del 1930. Realizzata, in quell’anno, ad olio su una tavola con i lati maggiori di un metro di lunghezza (133,7×117,3 cm.), l’opera presenta sul retro un bozzetto che Bonichi considerò da scartare. Del resto, di studi ne aveva fatti diversi. Non si trattava solo di disegni, ma pure di altri oli come quello conservato nella Collezione Mattioli di Milano, oppure l’altro del Museo d’Arte Contemporanea di Firenze. Si sa che Scipione dipinse il suo capolavoro nello studio di Mazzacurati in via Flaminia, come racconta l’amico pittore in un articolo apparso su L’Europeo nel giugno del 1965 e si sa anche che Gino Bonichi da molto tempo si misurava con questo tema. Leonardo Sinisgalli, nel suo Furor Mathematicus, pubblicato a Roma nel 1944, narra la storia di questo capolavoro, rammentandone, sia pur sinteticamente, il percorso creativo: <>. Come si vede, il punto di partenza per il capolavoro di Scipione era stato il Ritratto di papa Innocenzo X di Velázquez, quello che Sinisgalli scambia per un cardinale, origine di tutti i fraintendimenti sulle figure ecclesiastiche. Vale allora la pena di riflettere, sia pur brevemente, sul significato reale del capolavoro del pittore spagnolo per capire come, da lì, a cascata, si sia ingenerata una errata interpretazione di quella figura che ha influito tanto su Gino Bonichi e la sua famiglia d’artisti, quanto sulla memoria collettiva che ha in Bacon (1953) il punto di non ritorno nella valutazione negativa del ruolo politico della porpora ecclesiastica (che dal potere dovrebbe rifuggire), declinata in questo senso già dalla letteratura di Alfredo Testoni (1859-1931), la cui commedia su Il Cardinale Lambertini, futuro Benedetto XIV, pur dimostrando grande stima per il presule bolognese, non lesinava critiche alla classe cardinalizia. Del resto, più tardi, anche il cinema di Fellini, con quel capolavoro nostalgico che fu Roma del 1972, descrive negli stessi termini la Curia pontificia, non senza tener presente opere della serie del Cardinale seduto, fuse in bronzo fra gli anni Cinquanta e Settanta del secolo scorso, da Giacomo Manzù (1908-1991). Dunque, alla radice di questo ricco filone iconografico c’è quel capolavoro assoluto che è il Ritratto di papa Innocenzo X dipinto verso il 1649 da Diego Rodriguez de Silva y Velázquez che, per rispetto, l’artista inglese non volle mai vedere dal vero quando – nel 1952 – passò da Roma. Tuttavia, l’interpretazione che Francis Bacon (1909–1992) offriva dell’indole più intima del suo prelato era quella terrorizzata ed urlante della balia che grida nel grande film di Ejzenstejn La corazzata Potëmkin, un’altra immagine che l’aveva davvero impressionato e che sovrappose alla prima.
Questa interpretazione “baconinana” ha finito per sovrapporsi del tutto al capolavoro di Velázquez corrodendolo con una componente di violenza che, tuttora, impedisce di cogliere il significato primario del ritratto originale intriso, invece, di una sottile, intelligente, vena auto-ironica certamente voluta dall’artista spagnolo.
Forse fu Filippo IV di Spagna in persona a sollecitare il suo pittore di corte, Diego Rodriguez de Silva y Velázquez, inviato in Italia per reperire arredi per la reggia dell’Alcazar a Siviglia, perché realizzasse un ritratto del pontefice. Il papa accettò di buon grado, di sicuro dopo aver ammirato il dipinto che ritraeva Juan de Pareja, il servo mulatto al seguito dell’artista spagnolo, esposto al Pantheon ed eseguito appositamente per esibire le straordinarie capacità del maestro. Così si narra che, quando Giovanni Battista Pamphilj, questo il nome del papa, vide la propria effige dipinta sulla tela con tanta efficacia e realismo, si sia lasciato sfuggire: <>. Un giudizio che, leggendario o meno, coglie nel segno di una scelta stilistica intesa ad accantonare ogni eventuale idealizzazione, a tutto vantaggio della più vera dimensione umana del pontefice, nota ai contemporanei per la sua burbera apparenza e per un carattere collerico e difficile.
In realtà, ben lontano dal livore di Bacon, il punto focale del dipinto, ossia quello che giustifica l’espressione accigliata del pontefice (che, però, ha ispirato anche il pittore inglese), non risiede tanto nel volto, quanto in quel foglietto che papa Pamphilj tiene in mano. Si tratta di un particolare che, in genere, viene trascurato, ma che, invece, è il motore di tutta la storia. Sulla piccola pergamena ripiegata, infatti, si può leggere:<> che funge anche da firma. Si tratta di un espediente di grande intelligenza che crea i presupposti di una narrazione, sia pure accennata, sufficiente a giustificare l’espressione e il piglio del pontefice. Innocenzo X pare visibilmente contrariato dalla visita di questo sconosciuto che pure si presenta con credenziali così altisonanti. L’ultima parte del biglietto, che va sciolto come <>, in spagnolo <>, lo accredita come “cameriere” del re di Spagna, ovvero alto funzionario di corte. Si noti, inoltre, la cortesia di scrivere in italiano per rispetto al pontefice. Tutto questo, dal momento che l’emissario del biglietto è lo stesso autore del quadro, tutto il breve racconto non si configura altro che come una riflessione sulla vanità della fama e sul come sia del tutto inutile far bella mostra dei propri titoli. Così, probabilmente, Velázquez ha voluto fissare sulla tela il momento in cui si è trovato per la prima volta (prima di questa commissione) dinanzi al papa, il quale sembra proprio chiedersi con aria contrariata chi sia questo ignoto signore che viene dalla Spagna a importunarlo. Come si vede, quella dipinta dal pittore spagnolo, s’ispira ad una realtà ben diversa da quella immaginata da Francis Bacon, venata da una forte vena autoironica che si è persa non solo nella lettura legittima degli artisti che si sono succeduti nei secoli, ma – purtroppo – è stata del tutto ignorata dagli storici dell’arte che non hanno tenuto nella dovuta considerazione il biglietto che il papa tiene in mano.
Infatti, un capolavoro – quando è tale – mantiene una forza vitale così grande da proporsi come fonte d’ispirazione anche quando il suo significato sia del tutto dimenticato o venga addirittura stravolto.
Per questo Gino Bonichi, come Bacon e gli altri che lo seguiranno, era pienamente legittimato a fermarsi al carattere più superficiale del dipinto, cogliendone però, un valore universale, ovvero quello che fa stridere l’accostamento del potere con il messaggio di Cristo.
Così, anche le misure della tela del capolavoro di Velázquez (141×119 cm.) ricordano da vicino quelle della tavola di Scipione. L’impressione urticante che suscita la tavola di Bonichi, fu percepita da subito, come dimostra il fatto che – come ricorda Sinisgalli nel testo già citato – la famiglia del cardinal Vannutelli non l’ha <<… voluto mai… e ancora oggi gli eredi del Decano si lamentano di vederne la riproduzione nei libri e nelle riviste.>>. Del resto, il quadro fu mandato alla Biennale di Venezia e <<…solo per un miracolo non finì fra gli scarti, finché non ha trovato requie a Valle Giulia…>>, ricorda ancora Sinisgalli che, però confonde la Galleria Comunale d’Arte Moderna dove, in realtà, è conservata l’opera (inv. AM 1081) con la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, appunto a Valle Giulia, non lontano dal museo etrusco e dalla Facoltà di Architettura che prendono lo stesso toponimo. Lo scorcio di Piazza San Pietro con l’obelisco, la grande cupola, le sagome delle statue del colonnato, stagliate su un infuocato tramonto romano che riprende i toni della mantella cardinalizia, sono tutti elementi di ambientazione che fanno del Cardinale una sorta di anima di Roma. Al contrario, la grande chiave appoggiata alla balaustra, il corvo che vi si è appollaiato sopra e il dado posato per terra, sono tutti simboli assai inquietanti che trovano un corrispettivo nella figura che furtivamente sbuca dalla spalliera dello scranno. Il corvo è un segno sinistro e il dado rimanda all’idea di fortuna, instabilità e perfino vizio del gioco, mentre la chiave è uno strumento di potere. Anche oggi si dice <> o <> o <>. Nel mondo romano, il sacerdote aveva le chiavi per aprire le porte del tempio e il dio Giano, dalla doppia testa, aveva quelle per aprire il nuovo e chiudere il vecchio anno. Per il Cristianesimo, il pontefice ha le chiavi spirituali date alla Chiesa da Cristo per aprire e chiudere le porte dell’Inferno e del Paradiso. In genere, infatti, le chiavi sono due, riprodotte in tutti gli stemmi, per aprire una chiave d’argento e per chiudere una d’oro, come quella dipinta da Gino Bonichi. Questo potere deriva al pontefice ed ai suoi delegati, da San Pietro, primo papa, che ha le c. del Paradiso. Vale la pena di ricordare che l’ultima miniatura del Salterio di Winchester (Londra, British Library), mostra un angelo che chiude a chiave le porte, che in realtà sono le fauci, dell’inferno. Questo è il potere che dovrebbe avere il Cardinal Decano che qui, però, si tinge di un’ombra sinistra per via della presenza del corvo e, soprattutto, del ragazzino (angelo o demone ?) che fa capolino dalla spalliera del trono.
In altre parole, quel che traspare dal capolavoro di Sicipione è un fetore di morte e di decomposizione che Benedetta Bonichi ha subito colto quando ha realizzato il suo Il Cardinale con la tecnica dei raggi x, stampando su tela o su carta preparata ai sali d’argento. L’immagine deriva direttamente dal Ritratto di papa Innocenzo X di Velázquez, come dimostra la posizione delle mani. La figura dell’alto prelato immaginata da Benedetta è vista in filigrana e la struttura scheletrica del personaggio emerge con prepotenza nel dialogo fra il bianco e il nero della radiografia. Al contrario, lo sfondo di tipo paesaggistico, con un profilo urbano che deriva dal capolavoro di Scipione. Infine, un tocco di modernità è asserita dalla presenza di occhiali.
L’idea di disfacimento coniugata con quella di un ecclesiastico, ritorna anche nelle opere di Claudio Bonichi come Il Concilio dove il pittore si abbandona ad una precisa citazione del Cardinal Decano che presta il suo volto ad un alto prelato in primo piano il cui busto, tagliato all’altezza delle spalle, si staglia sullo sfondo brulicante di una processione. Del resto, lo stesso Scipione aveva affrontato il tema specifico con lo studio del cardinal Vannutelli sul letto di morte, come fece pure Eso Peluzzi non solo in un disegno molto evocativo, con un frate dai grandi piedi in primo piano, tutto basato sui toni del grigio, ma pure nell’olio su tavola dipinto nel 1948 per il Vescovado di Savona. Il quadro rappresenta Monsignor Pasquale Righetti vescovo di Savona sul letto di morte ed oggi è conservato in collezione privata. Lo stile risente della lezione di Tiziano e di Velázquez, ma quel che preme sottolineare in questi casi è che l’evento morte ha, in questi casi, una dimensione naturale, senza le implicazioni che invece emergevano dalle opere esaminate in precedenza. D’altra parte, non è sufficiente dipingere un presule per evocare simili risvolti. Basti, a conclusione, ricordare il particolare di un affresco come quello che Claudio Bonichi dipinse per il santuario di Nostra Signora del Rosario a Monchiero, dove la figura di San Fedele, pur indossando la casula, si presenta come una nobile figura presa dalla sua condizione.
Uno dei dati che emerge dalla ricognizione che abbiamo compiuto intorno alla figura del Cardinal Decano e dei suoi derivati, incluso il capolavoro di Bacon, è quello del corpo. In particolare, l’attenzione di Scipione alla reliquia umana e metaforica del corpo esanime del cardinal Vannuttelli disteso sul letto di morte, vicina alla riflessione di Eso Peluzzi sullo stesso tema di un prelato in fin di vita, stimola la nostra ricerca intorno ad un altro dei grandi temi con il quale l’arte di tutti i tempi si è sempre misurata: la rappresentazione del corpo. Naturalmente, il tema è troppo vasto perché venga affrontato qui nella sua totalità. Come ho avuto modo di scrivere altrove, infatti, è il corpo con la sua rappresentazione, ad essere il soggetto più sensibile di un’epoca; tanto da definirlo – come mi piace –, la “cartina di tornasole” delle variazioni della Storia dell’Arte. Anzi, sulla base di una simile premessa, si potrebbe pensare che, in realtà, non sarebbe lecito considerarlo un tema di riferimento per la famiglia di artisti che stiamo seguendo. Tutto vero, se non fosse che il modo d’interpretare il corpo, ovvero il nudo, da parte dei nostri protagonisti non trovasse delle singolari consonanze che talora arrivano ad esser vere e proprie corrispondenze. Possiamo così individuare una serie di temi che si potrebbero riassumere come segue e che, di nuovo, sottolineano la cura ed il disagio di rapportarsi alla figura umana che viene travolta in una sorta di passione caratterizzata da un profondo sentimento di odio-amore che talora questi artisti faticano a dominare.
Dentro il corpo. Manichini e corpi smembrati. Contorsionisti.
C’è quasi una progressione nell’indagine che ci accingiamo a fare che, comunque, rifugge da un’interpretazione monumentale del corpo e del nudo perché anche quando Scipione s’incammina verso riflessioni sulla figura umana che sfociano in disegni come Uomini che gridano, oppure La disputa (I dioscuri), realizzato nel 1929 e pubblicato su <> due anni più tardi, il messaggio che se ne ricava è quello d’incertezza e fragilità. In particolare, il primo disegno è ispirato al Salmo 130 di cui è trascritto il primo verso: <> che, però, l’artista indica come Salmo 129 perché segue la seconda numerazione tra parentesi del testo veterotestamentario. Definito dagli esegeti biblici come <>, il Salmo altro non è che un’accorata supplica che si vuole concludere nell’attesa della redenzione. L’interpretazione di Scipione ha del miracoloso perché recupera, forse senza saperlo, la più antica posa della preghiera cristiana, quella con le braccia alzate: il gesto dell’orante al quale il pittore dà una nuova, diversa interpretazione in una breve lettera indirizzata a Enrico Falqui, dove possiamo leggere: <>. Questo moto di felicità che nasce <> è quello che trasforma l’Uomo in essere beato, ricco di Dio come si può leggere nel commento che il rabbino spagnolo Mošeh de Leon (1250-1305) indirizza alla spiegazione del Salmo, secondo la traduzione di Gianfranco Ravasi: <>. Bene, Scipione fa sentire – in quel gesto – tutto lo sforzo di raggiungere <>; ma nello stesso tempo, con quel passo malfermo, recuperato dalla posizione ancata del Diadumeno di Policleto, lascia trapelare tutta la fragilità della condizione umana che non sempre riesce a raggiungere le profondità nelle quali alberga la sicurezza del divino. Così, sui volti dei due uomini si disegna un sorriso che assomiglia più ad un pianto o ad un ghigno, piuttosto che ad un sonoro grido di gioia.
Diverso sembrerebbe l’altro disegno, quello dedicato a I dioscuri che si presentano giganteschi, ben piantati sulle gambe in mezzo al prato e all’ombra degli alberi. Ispirato alla campagna ciociara di Collepardo, dove Gino Bonichi risiedeva in quel 1929 per curarsi con l’aria buona del luogo, il disegno è condotto in punta di penna. È vero che la matrice della loro posa è classica, solare, ma ad un’osservazione più attenta, si vede che sono trasparenti. Sarà la tecnica per dosare la composizione, ma l’effetto è di nuovo quello della fragilità, ribadito dall’incertezza del tratto che s’interrompe continuamente e, spesso si fa tremolante.
I nudi di Scipione realizzati ad olio, poi, sembrano di fango, magari fango biblico, ma certo terra destinata al disfacimento. Non è un caso che, morente sul letto del sanatorio, Scipione volle accanto a sé l’olio su tavola intitolato Uomini che si voltavano, conservato oggi presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna (inv. 4558). A dominare l’intera composizione è la grande diagonale seguita dall’arto inferiore sinistro e da quello superiore destro, cui fa da contrappunto l’altra linea obliqua, più piccola, rappresentata dall’altro personaggio. Entrambi si voltano indietro ed entrambi sono color terra, come il paesaggio di sfondo ed il cielo tellurico che sembra esserne l’eco. In lontananza, un uomo avvolto in un grande mantello rosso, l’unico ad essere vestito. I due protagonisti, invece, sono nudi e sembrano girarsi a guardare, forse a salutare chi rimane al di qua del quadro, quasi con nostalgia. Anche in questo caso, quella che emerge è la fragilità, la pochezza e la tenera debolezza del genere umano. Una debolezza che passa per la corruttibilità del corpo con la quale Scipione, per la sua malattia, doveva fare i conti tutti i giorni.
Non stupisce, allora, che un’opera raffinata come il Caino e Abele addormentati, mostri il corpo di uno dei due come in una sorta di radiografia. Realizzato ad inchiostro su carta nel 1932, un anno prima della morte, il disegno pare aver scarnificato uno dei due personaggi, del quale sembrano potersi contare le coste, le vertebre, il cervello, le ossa degli arti, descritti a metà come elementi scheletrici ed ombre del corpo. Qualche cosa di simile accade anche in altri disegni, come Figure, realizzato in quello stesso anno, in Studi per la Flagellazione, e, soprattutto, in San Giovanni, un disegno del 1930 che pare davvero una radiografia. La scena del Santo appoggiato ad una parete, in compagnia di un improbabile cane, sembra quasi un’anticipazione delle opere di Benedetta Bonichi, ma quel che è certo è che, ad una osservazione attenta, è possibile individuare e riconoscere gli omeri, i femori, le coste, il bacino, rendendo il corpo del San Giovanni del tutto trasparente, portando così alle estreme conseguenze la diafana fisicità de I dioscuri disegnati l’anno precedente. Non deve stupire, però, questa idea del corpo trasparente nei disegni di Scipione, visto il suo continuo rapporto con la malattia e la necessità di monitorare da vicino, attraverso la tecnologia di allora – ovvero le radiografie –, le proprie condizioni di salute. In altre parole, Gino Bonichi aveva un rapporto stretto con il proprio corpo ‘trasaprente’, come dimostra un altro disegno, questa volta schizzato su una lettera indirizzata ad Enrico Falqui il 21 febbraio 1932. Racconta, infatti, l’artista all’amico: <> Accanto due polmoni nella gabbia toracica con tanto di diaframma e uno scarabocchio nero sull’apice del polmone sinistro che aveva un aspetto inquietante. Il corpo di Scipione, perciò, era trasparente e le due sacche polmonari ricordano assai quel bue squartato a metà che Benedetta Bonichi rese in radiografia per omaggiare Bacon, un altro artista che sentiva la precarietà del corpo e lo sfacelo della carne. Benedetta, però, non si ferma qui e costruisce due sculture di ferro che paiono comporsi sotto gli occhi di chi guarda, una con fascette di metallo lucide e fredde e l’altra realizzata con il fil di ferro che assomiglia molto da vicino a quella traccia indelebile di fantasia che la matita lascia sul foglio. Come si vede, proprio come quello di Scipione, anche il corpo nudo rappresentato da Benedetta è ‘trasparente’, vitreo eppure caldo di grandi emozioni. Qui inizia il viaggio che Benedetta intraprende nel corpo e che ancora oggi l’affascina. Come si vede, perciò, il rapporto di questi artisti con la fisicità propria ed altrui non è lineare, sereno ed ovvio, ma se nel caso di Scipione, è figlio di situazioni esistenziali, per gli altri rimanda all’idea del tarlo della morte che è subito pronto a deteriorare anche la bellezza più piena. È forse in questo senso che vanno lette le figure femminili senza testa che ritroviamo nella produzione artistica di Scipione (il Nudino del 1927), di Claudio Bonichi (Il sonno del 2004 e Il corpo senza volto dello stesso anno) e perfino di Eso Peluzzi (Disegno del 1951). Certo, non si tratta di teste mozzate (di queste ci occuperemo a breve), ma di teste nascoste o minimizzate perché è la posizione che ne giustifica lo scorcio oppure la mancanza apparente. Metafora del corpo mutilato, del corpo fatto a pezzi è il manichino da sarto che Peluzzi colloca come una presenza muta ed inquietante in diverse opere che hanno come soggetto la sartoria (per es.: La prova del 1944). Si penserà, naturalmente che sia del tutto naturale trovare un manichino in una sartoria, ma quando questo si presenta come una forma incombente (per es.: Sartoria del 1940), oppure si pone come contrappunto mutilo della donna che nella sartoria sta seduta, allora la percezione è destinata a cambiare. Perfino in un’opera come Atelier di Campagna del 1932, che pure è pregna di una luce dolce ed è caratterizzata da colori primaverili, la presenza del manichino con il vestito in controluce, riempie la stanza della sua impalpabilità fantasmatica culminante nell’inquietante scura macchia che mima il collo mozzo del manichino di velluto nero.
L’aspetto più singolare, però, è che il tema del manichino da sartoria ritorna anche nella produzione degli altri artisti della nostra famiglia, a cominciare da Scipione che ne enfatizza il valore simbolico di reperto anatomico, come accade in quel piccolo capolavoro che è Via Ottaviano, dove il rigattiere rammenta più un monatto improvvisato che un robivecchi della Roma del secolo scorso. Sul suo carretto, i busti dei manichini e le gambe disarticolate dei modelli di ceramica (allora non erano certo di plastica come oggi), fanno il verso alle ceree statue di Gaetano Zumbo e dei suoi Theatri Vanitatis, dove i corpi in decomposizione si accatastano uno sull’altro. Del resto, che Scipione attribuisse ai manichini un valore ben più ampio di quello legato al semplice oggetto, lo dimostra un disegno caricaturale come La terza saletta, pubblicato su «L’Italia letteraria» il 5 ottobre 1930 prendendo garbatamente in giro il quadro di Amerigo Bartoli Gli amici al Caffè, realizzato l’anno precedente. Legato ancora ad un linguaggio di tipo neo-impressionistico, Bartoli aveva dipinto una grande tela (oggi alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna) nella quale aveva fissato, come in una foto di gruppo, amici e colleghi, frequentatori, come lui, del Caffè Aragno di Roma. Alcuni possono essere chiaramente individuati, da Emilio Cecchi a Vincenzo Cardarelli, da Roberto Longhi ad Ardengo Soffici, da Giuseppe Ungaretti allo stesso Bartoli. Scipione, nel suo disegno, con ironia si diverte a sostituire alcuni personaggi con dei manichini da sartoria che certo alludevano alla poca perspicacia dei presenti, visto che forse entrambi sono senza testa.
Il manichino da sartoria che Caludio Bonichi ha dipinto nel 1997, è un’ulteriore modulazione su questo singolare tema che attraversa i mondi poetici di questi artisti. Per Peluzzi è una muta testimonianza, per Scipione è la metafora dell’esistenza vuota, per Caludio Bonichi è un monumento alla vanità, alla menzogna, alla fantasia o all’artificio rappresentati dalla presenza della maschera appesa al collo tronco del manichino vestito con biancheria intima femminile che trasuda – variazione sul tema – sensualità e mistero nello stesso tempo. Del resto, l’artista si diverte a giocare su queste ambiguità come nel caso de Il manichino e la vespa del 1998, dove il busto femminile di un modello di ceramica senza testa e senza gambe è posato sul piano di un muro, forse davanti alla vetrina del negozio di moda. Certo è che la ceramica color carne dipinta da Claudio Bonichi è troppo vicina alla vera carne, troppo morbido il seno del manichino che, guarda caso, non ha neppure una giuntura. Allora l’effetto è inquietante e il busto con le braccia posato sul muretto è in bilico fra la vita e la morte come un corpo fatto a pezzi. Che assomigli a La bambola di Adua del 2004, dove il fantoccio è facilmente riconoscibile ? Oppure si tratta di una donna vera fatta a pezzi, come in quella xilografia per il «Candide» di Voltarie che certo rammenta le straordinarie incisioni de I disastri della guerra di Francisco Goya ? Proprio sul filo dell’ambiguità si muove anche Eso Peluzzi quando aggiunge la mano di un modello di gesso alle componenti smembrate di un violino disposte in bell’ordine su un tavolino (Elementi di violino con mano di gesso, 1975). È il mondo dell’infanzia di Peluzzi che riemerge nel ricordo del padre liutaio e nella consapevolezza che la forma del violino ricorda molto da vicino quella del busto femminile, come del resto dimostrerà Man Ray con una celebre foto intitolata Le violon d’Ingres. L’accostamento allora non è casuale, ma voluto perché il pittore, come dimostrano le foto, aveva l’abitudine di disporre gli elementi del violino sul piano di posa per rifarli. Il violino, allora, è il corpo sonoro dell’uomo che Peluzzi spezzetta in un gioco che ricorda da vicino quello dei manichini di Scipione e delle bambole di Claudio Bonichi. Quel che affascina è l’idea del frammento, della scheggia, vera o riflessa che sia, come nel caso di opere come Ribes e specchio dipinta da Claudio Bonichi nel 1996, oppure Natura morta con uva, specchio e buccia di cocomero, del 1998, dove le specchiere ovali catturano l’immagine sensuale del seno femminile che si tinge del mistero della vita e dell’esistenza. Un espediente al quale Claudio Bonichi non disdegna di ricorrere come ne La donna d’inchiostro del 2002, dove un manichino rotto, tenuto insieme solo da un’anima di ferro, ha al posto della testa un frammento di specchio nel quale si riflette il volto lontano di una donna (vera o finta, volutamente mal si capisce) che qui trasferisce la propria immagine vitale.
Infine, c’è un tema, fra i tanti che ruotano intorno a quella galassia simbolica che è il corpo, che riassume bene l’approccio che i nostri pittori hanno nei confronti della figura umana, amata, ammirata e, nello stesso tempo, sofferta perché l’immagine stessa della fragile esistenza su questa terra. Mi riferisco a quella sorta di allegoria della fatica di vivere che, nell’arte di Claudio Bonichi, è La contorsionista del 1982. Figlia delle metope medievali di Wiligelmo e del lungo filone iconografico dei cosiddetti “tiratori di barbe”, nonché delle gemme gnostiche reinterpretate attraverso la fantasia allucinata di Bosch, La contorsionista di Claudio Bonichi aggroviglia il proprio corpo come un nodo dell’anima che subito diventa un groppo alla gola e un tuffo allo stomaco per lo sforzo di esistere. Bonichi tinge di erotismo questa immagine e la ripete in altre opere, magari come figura secondaria, come in Notturno del 1995, oppure in disegni e studi come quelli dedicati alla Promenade che pare la riedizione aggiornata delle donne conturbanti che Scipione disegna lascive su un divano. Lo schizzo fu pubblicato sull’«Almanacco Letterario» del 1931 quando l’artista era in sanatorio e dimostra una prorompente voglia di vivere condivisa da tutti gli artisti della nostra straordinaria famiglia. Lo dimostrano, se ancora ce ne fosse bisogno, due opere di Benedetta Bonichi. Una è una scultura in terracotta intitolata Giochi innocenti che appartiene agli esordi dell’artista e l’altra è un’interpretazione radiografica de La contorsionista che, a differenza di quella di Claudio Bonichi, tutta chiusa in una scatola di legno, s’irradia verso il cielo nero della lastra radiografica come una stella che ha la forza di una supernova.
Così, paradossalmente, l’immagine che meglio delle altre interpreta questo disagio dell’esistenza, riflesso nella difficoltà consapevole di rappresentare il corpo, finisce per rappresentare, meglio di qualsiasi altra cosa, la gioia e, soprattutto, la brama di vivere. In qualche modo, allora, è come se i nostri pittori avessero gettato la maschera per rivelarsi per quello che sono: innamorati dell’arte e della vita.
La riflessione sul corpo, però, ha – inevitabilmente – un punto focale: il volto, sempre in bilico fra la realtà della morte, la finzione della vita e viceversa; gli occhi sul mondo, il gusto per il travestimento e la metamorfosi. Tutti aspetti che furono trasformati in altrettanti nuclei tematici.
Volto, Maschera, Morte, Occhi
«Faccia» e «volto» sono due termini che, come significato primario, si riferiscono a quel distretto anatomico nel quale risiedono i principali organi di senso, ma che in subordine assumono il valore di «aspetto», «sembianza», «apparenza», proprio perché il volto o la faccia vanno considerati come l’elemento più importante della persona, vale a dire quello con il quale ciascun individuo si presenta agli altri. Pertanto, non deve stupire che la faccia o il volto siano sovrapponibili del tutto alla persona stessa. Si tratta, perciò, della sineddoche per eccellenza, dove la parte per il tutto, come nel caso della parola «testa», rimanda alla totalità dell’uomo. Prodursi in un’articolata riflessione artistica sul volto, perciò, significa porsi il problema della rappresentazione umana, con tutte le implicazioni simboliche, esistenziali ed estetiche del caso. Un’occasione che i nostri artisti non potevano certo mancare.
Per questo, per Benedetta Bonichi, i volti paiono calchi dell’anima, che si appoggiano, come inquietanti presenze al velo dell’esistenza e lo premono fino a forgiarlo con la propria forma. Il significato è ampio e diversificato perché dimostra come l’individualità di ciascuno di noi (e non è un caso che il titolo di queste opere sia Myself, ma c’è anche My sister e My father) finisca per essere riassorbita dal velo di Maya, dal grande fenomeno del mondo, dalla manifestazione del reale che nasce, cresce, deperisce e di nuovo si riorganizza. Benedetta, però, sposta il proprio punto di vista intorno a questo concetto del limite del reale pressato dall’energia di coloro che esistono e ribalta la sua prospettiva, non solo spostando la propria attenzione sulle mani che spingono questo velo come a voler uscire, ma interpretando, in altre opere intitolate •••••, la materia non più come limite da pressare, ma come vincolo da spezzare. Non è difficile vedere in queste ulteriori sue creazioni una rivisitazione dei Prigioni di Michelangelo; ma il linguaggio e le scelte sono assolutamente contemporanee. Il mezzo espressivo è la fotografia e l’immagine ferma per sempre un momento che potrebbe essere quello di una performance da guru della body-art come Stelarc o un’inedita Gina Pane. Così, la realtà e la materia che la costituiscono sono viste dall’artista come dei legacci con cui si misura la personalità dell’individuo che la tende e la modifica grazie alla propria esistenza. Talora, però, questi legacci si fanno più estesi e si trasformano in un velo che avvolge l’intera figura, quasi uno schermo, le cui pieghe possono addensarsi sul viso come ne La ragazza velata di Claudio Bonichi, dove la tensione esistenziale di Benedetta lascia il posto all’aspetto ludico ed inevitabilmente erotico. Così, un volto negato dietro il tulle nero, come fosse una maschera che non permette di percepire la bellezza del volto della modella, rimanda all’idea di mistero che, inevitabilmente, s’intreccia con quella di velato, di oscuro, di nascosto. Non per nulla, il tema della maschera è caro a Claudio Bonichi che, spesso e volentieri vi vede la morte, alla quale irride con i suoi scoppi di vita e con la scelta discinta delle modelle, come nel caso dello Studio per i travestimenti di Venere, dove la dea dell’amore (o più precisamente chi la impersona al momento) ha appena tolto una maschera tondeggiante per indossare quella a forma di cranio, pallida e bianca come l’altra che certo rimanda alla luna. Il tema della morte, infatti, è strisciante nei nostri artisti; sicché di tanto in tanto rigurgita e riemerge come un’antica litania che tocca le corde profonde di Scipione, con il suo De profundis, un pastello scuro nella cui ombra s’intravede il lucore della morte. Disegnato per il breviario latino appartenuto al gesuita Don Guido venne affiancato, da Maurizio Fagiolo e Valerio Rivosecchi, nella loro monografia sull’artista, alla partecipazione funebre alle esequie del pittore, dove si può leggere: <>. Allora quel «de profundis», scritto sul pastello del breviario, seguito dal numero 32 (un anno prima della morte), assume un valore particolare, quasi profetico, e dà ancora più forza all’antica illustrazione dedicata al Salmo 130 (p. ••), il cui incipit latino è proprio «de profundis». La fragile condizione fisica di Scipione doveva fargli sentire naturale, quasi familiare, la dimensione della fine dell’esistenza nei confronti della quale reagiva con la forza del suo rosso smagliante, spesso utilizzato al limite del verosimile, come in un Autoritratto del 1930, custodito oggi nella Collezione Forchino. L’impressione di un cranio appare, invece, come un’impercettibile impronta su un frammento di violino il cui curvo profilo coincide con il limite della calva, come ne fosse la componente principale. Si tratta di Luci e ombre su frammenti di violino, dipinto nel 1983 da Eso Peluzzi che considera, come si vedrà più avanti, quello strumento musicale come il suo alter ego. Non è questo l’unico caso in cui il pittore di Montenotte abbia rivolto il suo sguardo malinconico verso il tema della morte, come dimostra un disegno come Il Rosario per i morti, dipinto nel 1922, dove, sebbene non ci sia l’esplicita presenza dello scheletro, è del tutto evidente che il gruppo di anziani raccolto in preghiera, proprio a quell’argomento rimanda, così come, del resto, aleggia nei quadri dedicati ai ricoverati dell’Ospizio dei poveri, oggi di proprietà dell’Istituto Opere Sociali di Nostra Signora di Misericordia a Savona. Al contrario, un bel disegno dedicato alla Crocifissione si mostra assai più esplicito, anche se presenta di nuovo una sorpresa, ossia che la morte è un violinista. Sta lì, sotto la croce con il proprio strumento musicale in mano, come se avesse appena terminato di suonare o stesse appena per farlo. Il suo cranio sghimbescio ne fa un personaggio fra il tragico ed il comico: grottesco; forse è lo stesso Peluzzi, anzi lo è di sicuro perché dove c’è un violino c’è lui. Talora, infatti, i volti e i personaggi s’identificano con le cose più care e l’immagine di un uomo s’intreccia con quelle di oggetti che altro non sono se non proiezioni dei propri interessi, della propria creatività e, in definitiva, della propria anima. Lo dimostrano, per esempio, buona parte dei ritratti rinascimentali, spesso arricchiti dalla presenza di oggetti che descrivono il carattere, il ceto, la cultura del soggetto ritratto, come nel caso di molti ritratti cinquecenteschi, come Il sarto di Giovanni Battista Moroni (Londra, National Gallery) o seicenteschi come Il botanico di Bartolomeo Passerotti, conservato nella Galleria Spada a Roma. Eso Peluzzi e il violino sono la stessa cosa: l’uno è il ritratto dell’altro. Il pittore lo sa bene e per questo dipinge un celebre Autoritratto con frammenti di violino, dove, sulle tavole di legno che servono a costruire quegli strumenti musicali non sono disegnati solo le loro sagome, ma anche il volto dell’artista che pare lì pronto per essere ritagliato come fosse un pezzo di violino. Del resto, entrambi hanno un’anima e, ognuno dei due ne svela l’esistenza grazie al suono che nasce loro da dentro: è la voce del cuore, quella che supera lo scrigno del corpo, suggellato dalla maschera del volto.
Del resto, Peluzzi sente assai il tema della maschera. La usa almeno due volte in altrettante opere, rare nella sua produzione, perché si tratta di un progetto di locandina per un veglione carnevalesco del 17 febbraio 1950 e di Le maschere, appunto, esposto alla Biennale di Venezia del 1930. Bene, qui la maschera ha un uso improprio, nel senso che si sovrappone a personaggi apparentemente normali che vanno in bicicletta o posano come per una foto, cioè entra nel quotidiano trasformandolo in simbolico. Sovrapponendo la maschera ai suoi personaggi, Peluzzi “toglie la maschera” alla banale apparenza del mondo e ne svela il mistero. L’effetto è veramente straniante e le immagini realizzate da Peluzzi si caricano di una forza dirompente che lo trasformano in una sorta di Ensor piemontese.
Maschera, faccia, cranio, sono tutti elementi che si sovrappongono e, talora, si confondono, come nel caso dell’Avec Amour di Benedetta Bonichi dove una fanciulla sognante ha i lineamenti diafani della luna come pure quelli algidi della morte, ma anche l’aspetto carnevalesco della bautta.
Del resto, il fascino del travestimento attraversa tutta la produzione della famiglia Bonichi, a cominciare dal violinista con la testa da morto che Eso Peluzzi, alla maniera di Ensor, pone sotto la Croce. Va però detto che il re del camuffamento, fra i nostri artisti, è Claudio Bonichi che non sa (e non vuole) allontanare dal tema la componente erotica. Nascono allora opere come Ragazza che scherza con la luna del 1983, nella quale una sensualissima modella dalle trecce bionde, nuda a mezzo busto, ma con i guanti di seta, si balocca con la sagoma di una luna di carta, appena ritagliata, che ha un buco attraverso cui la fanciulla ci guarda. È questo un tipico esempio d’isoide creativa della famiglia Bonichi perché il quadro di Caludio pare l’antefatto artistico dell’Avec Amour di Benedetta, dove i temi della maschera, della luna e della morte s’intrecciano si fanno linguaggio poetico, come in un altro quadro di Claudio, La luna di quello stesso 1983, quando il pittore si diverte a dipingere una modella nuda che si affaccia ad una finestra e si copre il volto con una bianca maschera di forma ovale, che prende tutto il viso lasciando apparire solo gli occhi.
Proprio il tema degli occhi ritorna nella poetica della nostra famiglia di pittori, a cominciare dall’attenzione che gli dedica, forse in maniera più istintiva che consapevole, Scipione, almeno in certi casi come quello di un disegno potente come la Ciociara dove l’impiego sapiente dell’inchiostro finiva per sottolineare opportunamente la presenza degli occhi segnati da spesse sopracciglia, come segno del carattere e della personalità del personaggio conosciuto di certo nel corso dei suoi soggiorni, in quel lontano del 1929, a Collepardo. Sono occhi che riflettono un’anima, come quelli della Contadina delle Langhe o del Pittore Brilla dipinti da Eso Pluzzi con attenzione al limite della Neue Schlichkeit che proprio in quel decennio si affacciava alla ribalta del mondo artistico europeo. La dimensione naturalistica, dettata dalla volontà di fissare sulla carta un ricordo di vita e un’impressione in Scipione, però, lascia subito il posto al desiderio di un’interpretazione simbolica quasi surreale, in un disegno inquietante del 1930, a dispetto del titolo, che lo consacra a La calma, come recita la scritta autografa dell’artista. Campeggia, infatti, sullo sfondo di un paesaggio di sterpi e di fiori che paiono squassati dal vento, al centro, la sagoma diafana di un uomo che non ha nulla se non un paio d’occhi ‘galleggianti’ su una faccia priva di naso, di bocca e di orecchie. L’esatto contrario della calma: un fantasma uscito dall’animo inquieto di Scipione che si aggira fra i nodi d’inchiostro tracciati dalla penna nervosa dell’artista.
Per Claudio Bonichi, invece, gli occhi sono prima di tutto i vuoti di una maschera, come nel caso di Maschere e radici del 1992, dove le fronde di un rametto verde paiono conferire uno sguardo sognante a quell’oggetto adesso animato da una vita latente che solo il tocco magico dell’artista sa portare in evidenza. Il più delle volte, però, dietro la maschera – lo abbiamo visto – si nasconde lo sguardo sensuale ed ammiccante della modella: è lei che dà vita a quell’oggetto muto e vuoto, come l’anima strappa all’inerzia lo scrigno del corpo che, altrimenti, sarebbe una scatola vuota. Anzi, talvolta, neppure di maschera si tratta, ma di un semplice foglio di carta con due buchi da uno dei quali sbircia la modella, come in Dietro la maschera del 2008. Ammirando le opere di Claudio Bonichi, mi vengono sempre alla mente quegli splendidi versi di Marco Aurelio che così suonano:
Animula vagula blandula
Hosepes comesque corporis
Quæ nunc abibis in loca,
Pallidula, rigida, nudula,
Nec, ut soles, dabis iocos.
Con queste parole, che oggi, possiamo leggere sulle imponenti pareti di Castel Sant’Angelo a Roma, l’imperatore Publio Elio Traiano Adriano descriveva la nostalgia dell’esistenza che finisce con la dipartita dell’anima verso luoghi <<sbiaditi, freddi, desolati>>, lontani dalla gioiosa felicità del vivere, quando l’anima, con il corpo, di cui era <>, si abbandonava alla consuetudine di una relazione ludica che altro non era se non l’essenza stessa della vita. L’imperatore, infatti, dà per scontata una dicotomia fra anima e corpo che subito cessa d’essere contrapposizione quando ne definisce le condizioni ed i limiti. I due termini hospes e comes, ossia <> e <> rinviano ad un rapporto complesso ed articolato che, pur sottolineando la sostanziale diversità dei due termini, fino al punto che uno ospita l’altro, ne afferma la relazione solidale e amichevole. Non sarà difficile intuire che sotto la terminologia poetica di Adriano si celi la certezza che corpo ed anima siano due elementi complementari, indispensabili all’esistenza. Del resto, è quanto risulta dalle riflessioni religiose e filosofiche non solo prodotte dal pensiero greco-romano, ma pure da quelle ebraico-cristiane e da quelle più propriamente orientali di cui, però, non potremo occuparci per non uscire dal tema che intendiamo affrontare. L’invito finale, però, era ad avviarsi nel mondo delle ombre con gli occhi aperti « apertis oculis introibo mortem». È dunque questa la speranza pagana di Marco Aurelio: rimanere con gli occhi aperti anche dopo la dipartita da questa esistenza terrena, quasi che – una volta travalicato il muro della realtà – non più «specchio dell’anima», come diceva il grande Plinio il Vecchio, ma anima stessa diventino gli occhi del nostro essere. Indubbiamente, infatti, questi preziosissimi organi non sono solo una sorta di straordinarie ‘macchine fotografiche’, ma molto di più. Non soltanto, offrono luce al volto, ma finiscono per identificarsi con la vita stessa, esteriore ed interiore. Allora si spiega bene perché Claudio Bonichi li abbia così enfatizzati, al punto da trasformarli in protagonisti assoluti delle sue creazioni come lo studio per la Maria Callas dove è solo l’occhio sinistro della grande cantante lirica a campeggiare su un foglio color crema su cui, in basso, sono dipinti magistralmente due mozziconi di sigaretta. Realizzato nel 2006, il disegno fu esposto ad Ischia per la mostra collettiva intitolata La casa dei giochi. Omaggio a Luchino Visconti. Il tema degli occhi ritorna poi in un disegno dell’anno successivo, nel quale affiorano occhi disegnati a matita che campeggiano su un foglio invecchiato dal tempo su cui si legge appena una poesia o, forse degli appunti del poeta che riflette sulla forma degli occhi. È uno studio per Niente, il disegno a tecnica mista dal quale, invece, ironia della sorte, questa presenza ‘oftalmica’ sarà del tutto bandita. Degli stessi anni è anche Come una rosa nel bicchiere, dove l’occhio non è più disegnato, ma ritagliato da una foto al computer ed appiccicato al foglio come la foglia ed il petalo di rosa veri che dialogano con l’impronta del bicchiere che si trova all’angolo opposto. È un foglio fitto di appunti leggeri, disegnati e scritti, che ruotano intorno al motivo della rosa nel bicchiere.
Alle nuove tecnologie, invece, ricorre Benedetta Bonichi quando si avvicina a questo stesso tema. Allora l’occhio diventa letteralmente lo specchio del mondo esteriore ed interiore, in una clip, come si dice oggi, che si accompagna a 5 foto e che s’intitola Eyes: inside, io, la caverna. Non è difficile vedervi reminiscenze platoniche e l’attenzione al mito come filo d’Arianna che collega l’io, l’ego, il super-io, l’Io hegeliano e, ironia della sorte, perfino il piccolo schermo digitale alla presa di alimentazione. Dentro quell’occhio fotografato c’è tutto ed il contrario di tutto: il riflesso di Benedetta, protagonista assoluta perché contenitore (l’occhio è il suo) ed attrice (è lei che si muove riflessa nell’iride), ma anche l’universo di una stanza che è la camera interiore dell’anima e la tautologica presenza del mondo.
In altre parole, volti, crani, occhi, maschere operano una metamorfosi della figura dipinta che si anima di vita propria e s’incammina verso un mondo diverso, quello della pittura, popolato di personaggi impossibili, nati dal vaso di Pandora dell’animo umano, a metà fra sogno ed incubo.
Metamorfosi: Sirene, Minotauri e Mostri.
La dimensione onirica, infatti, appartiene sicuramente alla poetica dei nostri pittori. Chiariamoci bene: quello degli artisti non è il sogno dei ‘comuni mortali’, ovvero il prodotto del sonno, cioè di quella attività elettrica particolare del nostro encefalo che permette all’unità psico-fisica del corpo di recuperare energie, di ristorarsi e, così facendo, entrare in quella fase REM, vale a dire Rapid Eye Moviments (ossia: rapidi movimenti oculari), che denota l’attività onirica vera e propria della quale ciascuno di noi ha esperienza e che, in maniera un po’ immaginifica, potremo definire “rigurgito dell’anima”. Per un artista, invece, sognare è soprattutto “far sognare”, ovvero insegnare a chi ama e osserva le sue opere, ed anzi attraverso di esse, a comprendere che la realtà che ci circonda non è solo quella delle apparenze e delle nostre certezze. Il sogno dell’artista trasforma la realtà ed apre nuovi orizzonti, magari utilizzando gli stessi identici elementi che la realtà stessa ci offre, ma che per il solo fatto di essere disposti in un certo modo o, per il contesto nel quale li pone il contesto pittorico, svelano quel lato onirico che, altrimenti, mai sarebbe emerso. È il caso di Eso Peluzzi e del suo Ritratto di Vittorio Sapetti imbalsamatore dipinto nel 1939. Se osserviamo l’opera del nostro pittore, a prima vista, non vediamo nulla di diverso da quello che potrebbe essere uno sguardo fotografico su un soggetto del genere, ossia dell’immagine celebrativa di un professionista della tassonomia nella sua bottega di lavoro. Eppure, quella che si respira è un’atmosfera diversa che, rimanda, oltre tutto, ad una cultura artistica molto precisa, quale quella di van Eyck o Antonello da Messina che avevano l’abitudine di firmare su un foglietto appeso su un asse di legno dipinto nel quadro o appoggiato sul davanzale di un’ipotetica finestra. Qui Eso Peluzzi riprende l’idea e scrive il nome dell’uomo ritratto su un biglietto appeso alla cornice del banco da lavoro. L’altra idea che aleggia chiaramente in questo quadro, è quella della Wunderkammer, o «stanza delle meraviglie» ossia di quel tipo di collezioni che andavano di moda alla fine del XV e del XVII secolo e che avevano uno degli esempi più importanti in quella di Athanasius Kircher, il gesuita che aveva provato a tradurre i geroglifici dell’obelisco che aveva ritrovato al Circo Massimo e che Bernini collocò in cima a quel capolavoro che è la Fontana dei fiumi. Allora il signor Sapetti non è più quel coscienzioso professionista che doveva essere, ma diventa lo scienziato naturalista di un’epoca lontana immerso nella sua stanza da collezionista, quando l’indagine curiosa sulla natura si arricchiva di leggende e di stupore. Non basta, però: a ben guardare, dietro la testa del signor Sapetti s’intravede il profilo di un uomo che può essere un suo parente, un suo antenato, il ritratto di un altro tassonomista, ma che comunque sia, amplifica visivamente il valore del volto del nostro protagonista. Infine, in alto, la parete della bottega si conclude con un quadro che rappresenta la veduta di una città sul mare, il vecchio porto di Savona, che ‘sfonda’ il piccolo ambiente della bottega/wunderkammer e consegna a chi guarda l’impressione del viaggio (reale e metaforico) a chi guarda l’opera. Tutto questo, svela il lato onirico della realtà, toglie la maschera alla banalità delle cose e trasforma quello che poteva essere un semplice ritratto, in una vera immagine dalla straordinaria potenza evocativa. Non è il solo caso nella produzione di Peluzzi. Un altro esempio significativo è il pastello intitolato Autoritratto con la tuba del 1967. Qui, l’esempio è ancora più evidente perché il disegno prende le mosse da una fotografia del 1927 che ritrae l’artista nella medesima posa e con il medesimo abbigliamento, incluso l’ombrello e il rametto di olivo su cui è appollaiato un uccellino imbalsamato. Il fatto straordinario, però, risiede in questo: mentre la foto si pone sì come un documento assai interessante, ma comunque distante, il pastello sviluppa una carica poetica così potente che finisce per svelare un mondo interiore ignoto all’immagine della foto e la trasforma in un’immagine di sogno. Qui non c’è più solo l’autoritratto di Peluzzi, ma quel disegno dal colore sgranato, con il pastello sapientemente passato su una carta ruvida, rimanda ad archetipi veri e propri come Charlot, il funambolo “Signor Bonaventura”, il “fidanzatino” di Peynet, inesorabilmente invecchiato. Un omino dei sogni, insomma, che la fotografia lasciava solo intuire. Del resto, in un altro disegno, intitolato Mes Passions, l’artista si fa un autoritratto simbolico, interiore, dove quell’omino con la tuba danza in un mondo di sogno, popolato degli oggetti cari al pittore come la sua tavolozza, il frac con le code, il riferimento alla musica e all’amato violino. Allora, l’artista sogna ad occhi aperti e trasforma la realtà in qualche cosa di diverso. C’è una vera e propria metamorfosi, come nel caso di Scipione e del Risveglio della bionda sirena dipinto nel 1929. Si dirà: beh, per forza; c’è la figura mitologica della sirena ! Non è così. Il capolavoro di Scipione trasforma in qualche cosa di diverso anche il mito e lo fonde indissolubilmente con la prospettiva dei modelli precedenti come le “odalische” di Ingres, di Goya e, soprattutto, di Delacroix, non di rado riverse su cuscini e divani coperti da pelli di pantera, l’animale che nell’antica tradizione rappresentava il furor dionisiaco. Vale poi la pena di ricordare che all’origine di questa immagine ci fosse un sogno di Antonietta Raphaël, la consorte di Mario Mafai, che il celebre marito ricorda in una lettera dell’agosto del 1925, il cui passo più importante è: «…Io cercai per parecchi minuti di dove venisse quella voce, non molto profonda ma simpatica. E poco dopo vidi che era una sirena emergente dalle acque del lago di Perugia dalla bellezza squisita, con uno specchio in una mano e pettine nell’altra e mentre si specchiava, ravvivandosi i bei riccioli d’oro, ammirava se stessa…». Ad Antonietta, Scipione regalò un disegno che ancora oggi possediamo (collezione privata, Torino) e che rispecchia quasi del tutto la versione definitiva, arricchita dalla forza dirompente e sensuale del colore. Sogno e realtà s’intrecciano e, sotto la potente azione del pennello del pittore, la seconda lascia il posto al primo trasformando Antonietta in sirena e la pelle di leopardo stesa sul divano di casa Mafai in quella straordinaria soluzione visiva che il capolavoro di Gino Bonichi ci regala.
Metamorfosi, dunque. Tutto è metamorfosi: la matita che segna il foglio, il colore che copre il bianco della tela, le pennellate che si susseguono; ma pure le forme e le situazioni che si svelano, come in Amore. Venere e Marte di Claudio Bonichi, dove l’occasione di una posa fotografica si trasforma in una riflessione sull’apparenza e sulla sensualità con un bimbetto nudo nel ruolo di fotografo, mentre una coppia pure nuda, ma con le maschere sul volto, vuole essere una riflessione sull’idea del travestimento e della trasformazione. La vita ti cambia e quello che può apparire in un modo, finisce per essere in un altro, come La bella e la…maschera, invece che la “bestia”, magistralmente disegnato da un Caludio Bonichi che certo guarda al Ratto di Proserpina di Bernini. Qui è la maschera a conferire l’aspetto bestiale all’ipotetico rapitore della bella che gli sta in braccio; ma che forse è più il suo amante che il suo aguzzino. Allora le apparenze si rincorrono e non sempre tutto è chiaro. L’orrida testa che conclude il corpo sensuale della modella dipinta da Claudio nell’Anires sarà vera o una maschera ? Non lo sapremo mai; ma non è importante perché quel che importa è capire che la realtà non è mai quella che sembra. Il compito dell’artista è svelarne il sogno e il mistero. Si riaffaccia, allora, il mito della sirena che il nostro pittore sviluppa in parallelo a quello di Scipione perché le soluzioni adottate non sono neppure tangenti. Eppure, il fascino e la qualità si confrontano, anche se le opere di Claudio Bonichi svelano una sensualità non più aggressiva come quella di Scipione. Si pensi ad opere come La sirena ferita del 1988, dove quel che di cruento poteva esserci in una simile immagine viene stemperato in un’atmosfera onirica e delicata che pare transitare dall’incubo al sogno. Il tema della sirena ritorna diverse volte nel mondo poetico di Claudio Bonichi e si fa quasi emblema della metamorfosi, quella fisiologica dell’elaborazione del tessuto pittorico e quella dell’anima che sbircia il sogno dietro le apparenze del mondo. Nascono così opere come Luna Park dove una “centauressa marina” dalla coda di pesce sembra abbandonata da una parte come un giocattolo rotto. Ne Il concerto del 1980, invece, la figura della sirena è dipinta, in un organetto meccanico, al posto del nastro musicale di cartone forato che, doveva fornire produrre magicamente quella musica automatizzata. Qui l’artista fa riferimento alla natura sonora della sirena, quella cui si riferiscono, in senso negativo, Omero nel celebre episodio dell’Odissea (XII) che vide Ulisse lottare contro quelle armonie ammaliatrici e fatali; in senso positivo, Platone che – in un celebre passo della Repubblica (X, 617B) – ne descriveva la funzione come depositarie dell’armonie del cosmo, visto che su ciascun pianeta una sirena cantava una nota di un solo tono adeguata alle scelte del fuso della Necessità intorno a cui ruotava questo immenso carillon grande come lo spazio siderale. Ironia della sorte, Il concerto di Claudio Bonichi, com’è documentato dalla monografia pubblicata nel 1990 da Maurizio Fagiolo dell’Arco sul pittore di Novi Ligure, fu per vari anni proprietà di un collezionista che lo teneva accanto alla mitica tela con il Risveglio della bionda sirena di Gino Bonichi, detto Scipione. Forse, perciò, era un destino che Claudio Bonichi si occupasse di questo tema con opera come La sirena del golfo di cui qui pubblichiamo alcuni studi del 2006, ma che come si è visto iniziava ben da prima, dai disegni del 1979 come quello che ritrae la mitica figura ridotta a scheletro e abbandonata sulla sabbia come una vecchia lisca di pesce. Una soluzione sulla quale tornerà Benedetta Bonichi con la sua Sirena del 2001 che, però, a differenza di quella di Claudio, non solo è viva e vegeta nonostante l’impianto radiografico, ma si appresta ad un atto cannibalico, mangiando un povero pesciolino. Realizzata su carta preparata ai sali d’argento, la nuova sirena di Benedetta è il reperto archeologico della fantasia, ovvero la dimostrazione che i sogni hanno un’oggettività concreta fino al punto che si possono radiografare, osservarne lo scheletro e contarne le costole, come in Metamorfosi. L’araba fenice dove una donna dalla testa di uccello si muove sul bordo dei sogni, fra la realtà radiografica e la fantasia dell’invenzione metamorfica. Certo, il rischio è che dal vaso di Pandora dell’anima del pittore o, forse, come direbbe il grande Francisco Goya, dal «sonno della ragione», nascano mostri, magari senza ali di pipistrello, ma con la statuaria bellezza del mito. Così, Metamorfosi dipinto da Claudio Bonichi nel 1998 s’ispira alle immagini arcaiche dei Centauri, allora, letteralmente metà uomini e metà cavalli nel senso che equine erano solo le zampe posteriori ed umane le gambe davanti. Rotto come un antico giocattolo di terracotta, il centauro di Bonichi, però, è femmina, come femmina è il Minotauro del 1991. Un Minotauro-donna non si è mai visto né sentito e d’altra parte anche il pittore lo sapeva perché il suo è un gioco, dal momento che quell’essere mitologico, adesso, è il risultato di un travestimento. Quella del Minotauro è solo una testa di cartapesta indossata da un’avvenente modella e subito appare il mostro che, però, tutto trasforma in teatro, ossia in vita, in inganno e in metamorfosi. Monstrum, in latino, vuol dire «straordinario» e le figure che escono dalla fantasia di Claudio Bonichi sono davvero fuori del comune, come quella xilografia del 1975 pensata per il Candide di Voltaire che mostra l’abbraccio impossibile fra un enorme lemure e una donna. La presenza femminile, come si vede, è una costante nella poetica di Claudio Bonichi e la sua declinazione inconsueta, ossia mostruosa trova il suo culmine nel Mammababau del 1981, dove – di nuovo – è il travestimento a rendere insolito l’aspetto dell’imponente protagonista, ammantata da un elaborato cappuccio nero che fa da corolla ed una maschera dello stesso colore, fra veli trasparenti e sete traslucide che lasciano però intravedere un seno prosperoso da matrona. Qualche cosa di molto simile, nello spirito, alla Meretrice o alla Cortigiana romana che Scipione dipinse nel 1930. Come la prima, anche la Cortigiana è una speciale declinazione dell’universo femminile che si rivela come il trememendum dell’eterno femminino. Un po’ come La Donna a cavallo della Bestia di apocalittica memoria, che Scipione disegnò ad inchiostro nel 1930, ispirandosi appunto al XVII capitolo del libro giovanneo. Le scelte dell’artista sono, infatti, inquietanti e presentano la protagonista in groppa ad un toro, con i seni al vento divaricati come le corna dell’animale che procede a testa bassa. Non si pensi, però, che l’accostamento sia una forzatura, perché la “Donna dell’Apocalisse” è una prostituta, dice il libro sacro, e quindi la consonanza con la tavola dedicata alla cortigiana appare nel merito; né sembra fuor di luogo sottolineare la coincidenza dell’anno che rivela come questi temi interessassero in quel momento l’artista. In tutti questi casi (Claudio Bonichi compreso), l’incontro del pittore avviene con la dimensione straordinaria e sacrale del mondo femminile, anche se, in tutti questi casi, il concetto di “mostro” diviene morale, sia pure con una differenza. La meretrice romana, finisce per presentarsi come l’anima sciatta ed affascinante della città eterna. Il quadro, infatti, è strettamente legato alla realtà traumatica che sta vivendo la città, con gli sventramenti poco lontano dall’area della colonna Traiana per realizzare il percorso di via dei Fori Imperiali. Scipione allude a questo doloroso periodo riproducendo lo scorcio del monumento romano, della chiesa di Santa Maria di Loreto e della chiesa dedicata al SS. Nome di Maria; ma se la tavola fosse stata di qualche poco più larga, si sarebbe potuta osservare la Torre delle Milizie sopravvissuta al cumulo di rovine della miriade di casupole appena abbattute. È questo il mostro della quotidianità e della follia dell’uomo che distrugge se stesso e la propria storia. Allora l’anima di Roma scappa, e saluta con il fazzoletto mentre cammina con passo incerto, come la Dulle Griet di Bruegel, ossia Greta la pazza. Anche il volto della meretrice (forse proprio la «Grande Meretrice» giovannea) di Scipione è segnata dal velo della follia, la stessa che squassa la città in quel periodo.
Tentacoli, pettine e musica. La difficoltà più grande incontrata in questo mio tentativo di sistematizzare i temi in termini ricorrenti o “isoidi creative” come mi sono permesso di chiamarli, è stata quella di separare i temi l’uno dall’altro anche se, in realtà, il flusso delle idee, delle invenzioni, dei soggetti e delle soluzioni che affollano la mente di un artista è fluente e continuo. Distinguere, separare e raggruppare è un’impresa che a che fare con il concetto stesso di “anatomia”, nel senso letterale della parola (dal greco anatèmno «taglio da su a giù»; «seziono» per l’appunto); il che significa procedere in maniera del tutto innaturale nell’analizzare un organismo (come quello creativo) che, in definitiva, è un’unità inscindibile. Se a questo si aggiunge che non è per nulla errato considerare il fatto che non di rado i pittori (come Rembrandt, per esempio), nel corso della loro lunga carriera, non abbiano dipinto altro che sempre lo stesso quadro, oppure che i poeti (come per esempio Baudelaire), abbiano finito per scrivere sempre la stessa poesia, si vedrà bene come sia difficile e forse addirittura sbagliato, procedere in questo modo. Tuttavia, bisogna anche dire che un atteggiamento diverso non potrebbe condurre ad una riflessione critica, chiarificatrice che aiuta a crescere ed a comprendere il fenomeno che si ha davanti. Proprio questa lunga premessa, serve a spiegare che un tema come «tentacoli» poteva essere inglobato in quello di «mostro», mentre quello di «pettine» si avvicina al precedente per analogie di forme e, infine, la «musica» rimanda a quel concetto di armonia che è poi, in buona parte, alla base del concetto stesso di arte, anche visiva.
Spesso e volentieri, il dato di partenza è quello naturalistico, ovvero il polipo nel caso di «tentacoli». Un esempio è Il sogno di Ferdinando o Il sogno di Giacomino, secondo il titolo che più ci aggrada. Diviso da una linea diagonale che segna il limite del bancone del pesce la tela mostra – nella parte inferiore – una razza, un polipo e una spugna. Il quadro potrebbe sembrare una qualsiasi natura morta, se non fosse che dal buio dello sfondo, al di là del bancone, spuntano due mani. Una volta, com’è documentato da una foto, erano solo quelle le uniche presenze umane che rendevano l’opera misteriosa, amplificando il valore mostruoso dei tentacoli del polipo che pareva, così, un artiglio uscito da un incubo. Successivamente, il pittore di Macerata, aggiunse quella testa ironica che spunta dal buio a godersi la scena di chi guarda senza capire e a chiedersi chi sia che si affaccia sul mistero. Come si vede, già qui, lo spunto naturalistico iniziale subito si trasforma in qualche cosa di diverso, di traslato, di evocativo, come quando Scipione dipinse La piovra nel 1929. A farne qualche cosa di profondamente diverso da un’illustrazione scientifica o una natura morta di pesce, è la trasfigurazione dell’immagine che l’artista riesce a configurare. Come scrisse Antonello Trombadori nel 1941, ponendo la pittura di Gino Bonichi in rapporto con certo espressionismo europeo (penso a Soutine) era:«… il suo atteggiamento umano che è vocato a far poesia delle espressioni, delle fisionomie, degli aspetti caratterizzati della natura, trattenuta in una compostezza formale…» solo apparente, vorrei aggiungere «…della quale tono e luce sono il fulminante dispositivo.». Così il polipo si trasforma nella tentacolare piovra del vizio e della vita, con accanto una biscia di mare che allude alla nuova condizione di vita della ragazza in fotografia. Non per nulla, il sottotitolo della tavola è: I molluschi. Pierina è arrivata in una grande città. Allora tutto si spiega, tutto prende senso. Il tavolo di raso rosso è quello di una stanza da letto; la foto è quella di una ragazza che vuole farsi conoscere; la piuma è quella di un boa di penne di struzzo; i molluschi sono gli avventori che considerano Pierina una preda appetibile. Tutto si trasfigura sul piano morale e la luce rossa è quella che definirà le immagini osé delle foto o dei filmetti per soli uomini. Quei tentacoli sono i desideri lubrichi di persone di pochi scrupoli, in una Roma che è quella della meretrice e della cortigiana e che, un po’, è sempre stata così, dall’epoca di Messalina a quella della “dolce vita”. È allora questa l’anima di Roma, che si aggroviglia su se stessa, fra sensualità, peccato e mistero. Proprio come accade in un disegno di Caludio Bonichi del 1975, intitolato Il sogno. Lo scenario pare ispirato a Scipione, con il tipico palazzo romano che svetta sulla destra, ma al centro della piazza un’enorme tentacolare piovra che sta fra il mostro di ventimila leghe sotto i mari e il groviglio di stomaco che ciascuno di noi conosce quando s’innamora. Sullo sfondo cupole e minareti di un Oriente non meglio identificato. Cosa sono allora quei tentacoli ? Nodi dell’anima, oppure dita lubriche della sensualità che si spande ? Certo è che in Lunapark del 1984, le bisce che nuotano nell’acqua della ninfa dipinta sulla sagoma fotografica al di là della quale ciascuno può collocare il proprio viso nel vuoto della sua testa per sognare di vivere nel mito, sembrano le dita autonome di un mostro tentacolare che vuole ghermire la bella fanciulla.
Hanno invece, decisamente l’aspetto dei vermi che escono dalle vuote orbite dei crani raffigurati nel Giudizio Universale di Torcello, le anguille che popolano una delle prime opere (2001) di Benedetta Bonichi che, non per nulla, s’intitola Mask. Proprio come accade nel grande mosaico veneziano (ispirato al passo del Vangelo di San Marco – IX, 47,48 – che recita: «E se il tuo occhio ti sia di scandalo, cavalo. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché conservando tutti e due gli occhi, essere gettato nella geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue.»), i tentacoli/vermi di Benedetta, entrano nelle cavità orbitarie di crani radiografati come se stessero penetrando nell’intima natura dell’individuo. La scena è quella del pertugio e Benedetta non sa resistere al gusto per l’ironia che affiora dal sottotitolo: quattro variazioni angiografiche dell’aorta e pesci di paranza. I tentacoli, i pesci, i vermi che Benedetta rappresenta in modo tanto ambiguo quanto evocativo in un viaggio fra l’esterno e l’interno del corpo, poi, prendono forma di mostro in un’altra opera affascinante: La collana di perle realizzata, su carta preparata ai sali d’argento, nel 2002. L’immagine è di grande suggestione e raffigura un essere mezzo donna e mezzo polipo che si vezzeggia con la propria collana. È questo il tipico caso dell’artista che, utilizzando la propria sensibilità come il bastone del rabdomante, finisce per trovare una forma che pare scavata sul bordo della memoria. Che ne fosse a conoscenza o meno, è noto che questa particolare combinazione di donna e di piovra, trova un riscontro preciso nella figura di Scilla, scolpita, tra l’altro, nella monumentale cinquecentesca Fontana del Nettuno a Messina scolpita nel 1557 da Giovanni Angelo Montorsoli; oppure nel gruppo marmoreo della grotta di Sperlonga voluta da Tiberio per rappresentare le storie di Ulisse, dove però, l’iconografia rappresenta il terribile mostro con teste di cane e code di serpente. Certo è che la figura inventata dall’artista, che si balocca con la propria collana, sospesa negli abissi delle profondità marine, per il fatto stesso di presentarsi sotto la luce impietosa di una radiografia, si pone come reperto onirico, recuperato fra le pieghe di un incubo. Nonostante la natura inquietante, la creatura acquatica immaginata da Benedetta, comunica una naturale eleganza ed una sensualità che non hanno nulla da invidiare a quelle di una vera donna.
A volte può essere un oggetto quello che caratterizza una scena o un personaggio e il pettine può essere uno di quelli particolarmente evocativi. Immediatamente legato alla presenza femminile, il pettine è sicuramente uno degli strumenti più antichi per la cura della persona che rimanda a momenti d’intimità e induce a riflessioni su se stessi. Il tema ricorre, come un filo rosso, in buona parte della produzione della famiglia Bonichi, a cominciare dalle opere di Scipione come la Donna con il pettine del 1929, dove la granitica monumentalità della figura, si stempera nel gesto di portarsi il pettine al petto, come del resto accade nel quadro d’identico soggetto dipinto l’anno successivo dove però, la stessa modella lo brandisce come se fosse l’arma della sua potente femminilità ciociara. Declinazioni sul tema, poi, tornano in disegno come La toeletta, ancora del 1929, dove un enorme pettine campeggia sul tavolo tondo coperto da un tappeto a frange, insieme a spille e forcine di bellezza. È senz’altro l’anticamera di una casa di tolleranza, o di appuntamenti, come si diceva allora, come dimostrano le calze sparse per la stanza, il separé, di cui il pettine è il muto custode. Del resto, il disegno intitolato Agosto, come si legge dalla scritta, dove pure compare un pettine, pare il fotogramma successivo di questo ipotetico film erotico nel quale quello strumento da toletta, accompagna la sensuale procacità della donna distesa in un tripudio di peli e di capelli lunghi che scendono lungo le spalle. Gli esempi potrebbero continuare con la Natura morta con tubino dove, ancora una volta, il pettine è testimone di una serata mondana, i cui ‘resti’ sono rappresentati dal cappello a cilindro, dal bastone, dalla sciarpa e dal monile gettati a terra sulla camicia scura che qualcuno si è tolto in fretta e furia per tuffarsi nei piaceri della vita. A volte, infatti, gli oggetti e le loro forme sono ben più eloquenti di tanti discorsi anche perché il pettine, con i suoi denti, assomiglia non poco ad un polpo dai lunghi tentacoli dai quali emana la stessa sensualità. Ah, se gli oggetti potessero parlare – sembra dire quel quadro di Scipione –, chissà quante cose potrebbero raccontare! Proprio come gli strumenti da toletta della Fanciulla che si pettina di Claudio Bonichi, il cui volto ricorda assai quello di Benedetta poco più che adolescente. Un gesto misurato, il suo, come di chi si affaccia alla nuova condizione di donna che si lascia alle spalle quella di bambina. Il pettine è là, fermo sul piano della toletta, pronto a raccogliere le confidenze di chi sta crescendo. Chissà se a quell’epoca Benedetta Bonichi avrebbe mai potuto immaginare che da lì a qualche anno, da protagonista, sarebbe divenuta autrice di un’opera con lo stesso soggetto? Sicuramente non aveva memoria razionale di quell’antico disegno fatto dal padre, ma l’idea doveva esserle rimasta dentro per essere poi rigurgitata dal cuore e dalla mente come la scheggia ingombrante di un mito antico: quello di Venere che si pettina in eterno, per la gioia degli uomini di ogni epoca e per saldare il debito nei confronti della vita.
Donna come armonia e pittura come musica, sono alcuni dei temi che legano insieme il mondo poetico dei Bonichi. La musica, come direbbe il Poeta “discende pe’ li rami” della famiglia Bonichi a cominciare da Giuseppe Peluzzi, liutaio di grande abilità e padre di Eso Peluzzi, immortalato dal figlio come un vecchio profeta alle prese con la costruzione dei suoi strumenti musicali. Tuttavia, a prescindere da questa pertinente contiguità, la musica come tema viene più volte evocata nella produzione dei nostri artisti, come nel caso de La Musa dipinta da Scipione nel 1929, dove una procace fanciulla, vista di spalle, suona una mandola in un paesaggio agreste, recupero moderno dei concerti campestri di veneta memoria, da Giorgione a Tiziano. Non è infatti un caso che spesso, a suonare uno strumento musicale – nell’immaginario dei Bonichi – sia una donna, dal Circo immaginario di Claudio Bonichi del 1981 a La violinista del 2006 dove l’aspetto teatrale di quella tela, si stempera in una scenografica solitudine. Il che non vuol dire che non siano contemplate altre chiavi interpretative del tema musicale, come quelle tragiche di Benedetta Bonichi, i cui disegni rendono le note musicali incombenti sul piccolo pianista, preso dal furor creativo, oppure siano trasformate in esseri animati che si lanciano da un filo all’altro del pentagramma musicale. Forse sono le note suonate dagli strumenti di quei musici ischeletriti come Il violinista e il protagonista femminile (almeno a giudicare dalle scarpe) di Nona!.
Visioni.
Quel che si delinea allora, alla fine di questa lunga ricognizione, è una sorta di regno della fantasia popolato da esseri mostruosi, animali tentacolari, figure mitologiche come il Minotauro mimato o reale, la sirena dalla coda di pesce, oggetti significativi come pettini e violini, maschere e piume di struzzo. A questi aspetti si devono aggiungere i grandi temi amalgamati da un’interpretazione congruente di ciascuno di essi, come risultato di una sensibilità comune e di una creatività incontenibile che ha saputo declinare – con le immagini – il panorama interiore dell’anima di ciascuno dei componenti di questa singolare famiglia di artisti.
Allora, come si usa in questi casi, vogliamo chiudere questo singolare viaggio con un campionario d’immagini finali che possiamo definire “visioni” in quanto emblematiche della loro natura emotiva.
In questo senso, l’immagine che meglio sintetizza questa riflessione conclusiva, è il Narciso realizzato nel 2012 da Benedetta Bonichi. Concepito in quella dark zone indefinita che separa l’amore dalla morte, dove è difficile stabilire se il deliquio di cui si è vittima dipenda dall’acme del piacere o dal mancamento di chi inesorabilmente finisce per spegnersi, il Narciso di Benedetta, guarda tanto alla bellezza delle forme quanto al disfacimento del corpo. Così, dietro la maschera di marmo di un’antica statua classica, si dispongono i resti corporei di uno scheletro umano che forse quel bianco simulacro aveva ispirato. È un po’ la metafora dell’artista che, innamorato perdutamente di se stesso, finisce per perdersi negli abissi del proprio animo. Si aprono perciò quegli scenari interiori che un artista come Claudio Bonichi sa magistralmente riportare sulla tela, come ne La foresta che forse rappresenta la vera “selva oscura” di dantesca memoria. Le opere di Claudio sono istantanee di paesaggi inconsci, come La città dei giochi che probabilmente abita dentro ciascuno di noi e verso la quale ci incamminiamo quando siamo tristi e abbiamo bisogno della gioia della nostra infanzia trascorsa per affrontare i flutti del mare della vita. È il nostro approdo sicuro, ma fragile, senza il quale, però, non riusciremmo a vivere. È quello, infatti, il nostro Prato della memoria il cui muto custode è il cavalluccio di legno sul quale percorrevamo gli sterminati spazi della fantasia immaginandoci ora cavalieri senza macchia, ora principi lanciati al salvataggio della principessa chiusa nella torre. Il paesaggio raccontato dai pittori della famiglia Bonichi è però onirico anche quando ripropone un dato reale che finisce per essere trasfigurato in qualche cosa di diverso, visto con la lente del cuore e dell’anima. Così, gli Alberi secchi disegnati da Eso Peluzzi nel 1922 sembrano anticipare La foresta di Claudio Bonichi, mentre il Colle gigante assomiglia più alla ferita sessuale della Madre Terra che al dislivello ripido del grande colle. Allo stesso modo, nell’Autoritratto a Montechiaro, l’artista finisce per identificarsi con l’anima del suo amato paese, per divenirne l’interprete più lirico. Una posizione non troppo diversa da quella che assumerà Scipione nei confronti di Roma, di cui può ben essere considerato il genius loci. Il suo amore per la città eterna, incluso gli scorci che non ci sono più, come La via che porta a San Pietro (i Borghi), di lì a poco abbattuti dalla smania urbanistica di Mussolini (che interpretò, a dire il vero, un sogno a lungo accarezzato da molti papi, a cominciare da Alessandro VI), svela l’anima più profonda di Roma, fra grandezza e decadenza, silenzio quasi surreale – come in Piazzale del Laterano o Piazza San Giovanni che dir si voglia – e frastuono, a mala pena dominato, che irrompe in due splendidi disegni come Ponte Sant’Angelo e Il Foro Traiano.
Si assiste allora ad uno scontro interiore, fra le forze dell’istinto, del sogno, dell’infanzia e quelle della ragione, che produce, come ovvio, morti e feriti. Il risultato è Roncisvalle di Claudio Bonichi, dove caduti sul campo, sono i burattini di un antico teatrino da bambini, oppure La Battaglia di Benedetta Bonichi, che pare la scena tolta dal frontone di un tempio greco di cui sono rimasti soltanto gli scheletri degli dei.
Siamo, perciò, tutti invitati al convivio dell’arte, quello di To see in the dark, per guardare nel buio dell’abisso del mondo e fare un passo verso l’Eterno. I convitati di Benedetta, infatti, fanno gli stessi gesti dei due coniugi di terracotta del Sarcofago degli Sposi conservati nel museo di Valle Giulia a Roma, a dimostrazione che l’arte e l’umanità si ritrovano, anche a distanza di secoli, su quegli stessi valori visionari che la famiglia Bonichi ha rappresentato e rappresenta nel panorama artistico contemporaneo.
Marco Bussagli
La prima impressione che proviamo davanti ad un quadro di Claudio Bonichi
è quella di trovarci in un luogo di quiete, in una zona protetta dalle irritanti banalità del quotidiano.
Tutto sembra riposare nel silenzio, lontano da quella agitazione che crea ansietà
e stordimento e che trascina verso altri stordimenti.
La danza chiassosa del mondo si arresta per concederci, attraverso l’artista, un
un istante di pausa, per ritrovare ancora una volta il sentimento della bellezza, per
sentire, quasi con stupore, che qualcosa di magico esiste ancora e per assaporare le
vibrazioni dell’immagine davanti a noi ed il suo riflesso dentro di noi.
Marco Di Capua ha captato intuitivamente, nelle recenti opere di Claudio Bonichi,
“una straordinaria accumulazione di solitudini ” concentrate in quelle stanze della mente
che appartengono all’artista. Nonostante ciò quanta vita, quanti tremori, quanto desiderio di dialogare in quel silenzio di perla che avvolge le sue divinità lunari e il germogliare della natura: ogni oggetto è carico di forti e molteplici significati, ogni particolare rivela l’ impronta di corpi amati e non dimenticati, ogni sguardo trattiene in sé parole e richiami i trattenuti
dal pudore del gesto.
E qui la necessità della maschera e dello specchio, attori insostituibili sui palcoscenici
minimali di Bonichi: se la maschera scura, morbida come velluto, serve ad occultare
il trasparire dello sguardo e dei suoi ardori ,invitando nello stesso tempo chi
osserva ad andare oltre e sollevare il velo di Maya, a vincere ogni ritrosia.
Se la maschera è l’ammissione esplicita della necessità del travestimento, allora lo specchio è la forma della possibilità, l’immagine dell’altro, l’urgenza di tutto quello che, attraverso i sensi, noi non riusciamo a captare nella sua fisicità immediata e che comunque è li, fuori di noi, pronto per nuove avventure del corpo e della mente.
In Bonichi, talvolta lo specchio è rivolto verso il fondo del quadro, forte presenza opaca, pura forma geometrica dalla quale, come riconosce lo stesso artista, nascono altre forme, quelle fluenti delle sue veneri. Però nello stesso tempo l’ovale ricorrente grazie al riflesso del cielo è la finestra attraverso la quale il mondo esterno penetra nella dimensione definita del suo studio.
È vero tra le opere di Claudio Bonichi non esistono paesaggi e tutta la sua attenzione sembra rivolta a soggetti naturali- donne, fiori o frutti- collocati con cura e disposti con ordine in posa.; ma la sensazione del en plain air, degli orizzonti irraggiungibili , dei cieli aperti, è tutta concentrata in frammenti di aria libera e nelle atmosfere che illuminano i suoi specchi.
La Verità- se ci è concesso di pronunciare ancora una volta questa parola cosi difficile- potrebbe essere un gioiello nascosto in uno specchio; ho potuto verificarlo giorni fa, a Vienna: davanti alla “Fanciulla alla Toeletta” di Giovanni Bellini, immagini di purissimi accenti, dove certi dettagli si colgono solo nel gioco dei riflessi creati da un succedersi di specchi. Un’ analoga riflessione può essere proposta dinnanzi alle tele di Bonichi, senza che questo chieda di anticipare parallelismi che vadano molto oltre ad una predisposizione simile dello spirito. Ma se nelle solarità del maestro rinascimentale la visione neoplatonica compone l’immagine in un tutto sicuro e armonico, la scomposizione di ogni certezza consente oggi all’artista di assaporare la bellezza solo in frammenti, dove l’esistenza per un istante, possa ritrovare la dolcezza di un frutto maturo, la fragilità di un fiore che appassisce, la morbidezza palpitante di un profilo di donna come se fosse colto nel riflesso instabile di uno specchio inclinato.
Presentazione al catalogo Claudio Bonichi, Galleria Sala Parés Barcellona, Marzo 1995.
1979
M. De MICHELI, G. SEVESO, catalogo della mostra, “Festa Nazionale dell’Unità”, Castello Sforzesco, Milano, estate.
1983
M. DE MICHELI, “Il mondo misterioso e sensibile di Claudio Bonichi”, catalogo della mostra “Claudio Bonichi”, Galleria La Bussola, Torino, dal 9 marzo.
M. De MICHELI, catalogo di “Expo Arte”, Fiera del Levante, Bari, 22 – 27 marzo.
1984
M. De MICHELI, presentazione della mostra, “12 artisti a Villa Groppallo”, Centro Culturale di Villa Groppallo, Vado Ligure, 28 luglio – 18 agosto.
“Claudio Bonichi”, ABC, Madrid, 7 ottobre.
M. De MICHELI, “El mundo misterioso y sensible de CLAUDIO BONICHI”, in “DOSSIER Claudio Bonichi”, “Gaudalimar”, Madrid, novembre.
1985
M. DE MICHELI, catalogo della mostra “Premio per giovani incisori – Antonio Ruggero Giorni”, Premio San Benedetto Po, ottobre.
1987
M. DE MICHELI, catalogo della mostra “Claudio Bonichi”, Galleria La Tavolozza, Palermo, febbraio.
1993
M. DE MICHELI, G. SEVESO, catalogo della mostra “Trent’anni di arte per immagini a Milano”, Galleria Appiani Arte Trentadue, Milano, 30 novembre 1993 – 20 gennaio 1994.
1996
M. De MICHELI, “El mundo misterioso y sensible de CLAUDIO BONICHI”, G. GIORDANO, “El Destino es como la Ola del Mar que nos Arrastra”, B. PORCEL, “Anos, Frutas y Lunas con Claudio Bonichi”, M.
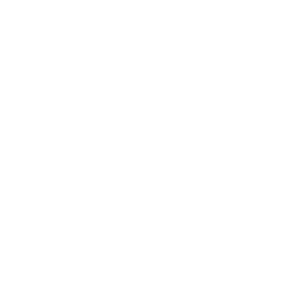

 Italiano
Italiano